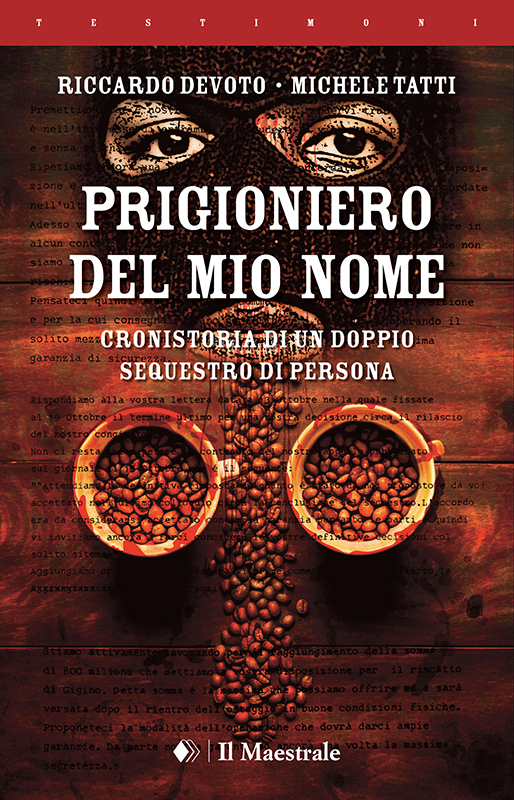Alberto Capitta (nato nel 1954 in Sardegna) è arrivato alla narrativa nel 1999, quando il suo primo romanzo, Il cielo nevica, fu pubblicato da Guaraldi. Dopo qualche anno (2004), l’approdo all’editore faro della sua isola, Il Maestrale, con Creaturine, libro che lo ha portato delicatamente all’attenzione del panorama letterario nazionale conquistando una finale al Premio “Strega” (2005) e il premio “Lo Straniero” nel 2006; proprio dalla rivista, e dal suo fondatore Goffredo Fofi, Capitta riceve i maggiori riconoscimenti critici. Nel 2007 il romanzo d’esordio viene rieditato da Il Maestrale, che pubblica anche il successivo Il giardino non esiste (2008) e, dopo cinque anni, Alberi erranti e naufraghi, che ha appena vinto il premio di “Libro dell’anno 2013” di Radio 3/Fahrenheit (poco dopo essersi aggiudicato, nel mese di settembre, anche il Premio “Brancati”).
A proposito di Alberi erranti e naufraghi, su «Internazionale» Goffredo Fofi ha scritto:
«Ci si chiede perché i tre precedenti romanzi di Capitta, il più originale dei nostri scrittori, non abbiano avuto il riscontro meritato […] Non è realismo poetico il suo, ma qualcosa di più profondo, che spinge al paragone con il magistero femminile delle Morante, Ortese, Masino e Ramondino, o con i toscani di ieri da Palazzeschi a Lisi, tra gusto antico del romanzo fiaba (con echi di Stevenson e Leskov) e l’esigenza di dire il più e l’oltre dell’esperienza attuale del mondo. […] Ecco un romanzo diverso e prezioso, mai lezioso, che i lettori “continentali” devono scoprire.»
Partiamo con la classica domanda sul premio appena conquistato: ti confrontavi anche con autori accasati presso grandi editori, per cui posso immaginare che non avessi i pronostici dalla tua. Durante la trasmissione, appena proclamato il tuo nome, abbiamo sentito che eri già quasi andato via per non perder il traghetto. È stata una sorpresa?
Arrivavo con un libro edito dalla casa editrice Il Maestrale, come poteva non essere una sorpresa? Naturalmente nutrivo le mie buone speranze, quelle si fa in modo di non perderle mai, ma erano giusto delle innocenti speranze e la consapevolezza che in casi come questi l’hanno vinta sempre i soliti editori. E invece questa volta…
Nei tuoi libri, a mio parere, si realizza un’originale commistione sensoriale: estrai gli oggetti, per esempio, tipici della percezione visiva, e li rielabori per renderli avvertibili anche dal senso dell’odorato, e così via in infinite combinazioni; l’abbattimento dei muri – non solo fra i sensi, ma anche fra gli esseri umani – è forse un obiettivo della tua poetica, in un’epoca nella quale non è invece raro constatare come le polarizzazioni e le logiche di appartenenza a un “gruppo” abbiano ancora grande forza disgregatrice?
La vista non è abusiva nel mondo dell’olfatto, e viceversa, ma entrambi partecipano allo stesso prodigio, una sola materia dove confluiscono le forme, le forme del mondo, dove tutto continua, il cavallo che continua nel palazzo che continua nell’occhio che continua nella nuvola. Certo, questo farebbe pensare a un’armonia ideale, alla possibilità di un’umanità pacificata, in regola con le leggi della natura e del convivere civile. Se si fosse abbastanza ingenui lo si potrebbe pure credere. Ma gli uomini ci hanno dato sufficienti prove contrarie nel corso della Storia, hanno compiuto stragi inverosimili di donne, di bambini, di eretici, di storpi, di sovversivi, di diversi. Questo non può mai essere dimenticato, non ci sarà poetica capace di risciacquare una simile memoria. E allora occorre proclamarla un’appartenenza, una posizione dalla quale battersi per contrastare i poteri forti, le pastette dei militari e degli Stati, occorre non abbassare mai la guardia, rimanere irrequieti, fedeli a un’idea di resistenza.
In Alberi erranti e naufraghi c’è una comunità di bambini che vive isolata in una foresta: un’idea simile la troviamo anche in un videogioco di ambientazione post-atomica, Fallout 3, nel quale una società di orfani vive in una caverna chiamata Little Lamplight: perché secondo te “l’età dell’innocenza” diventa oggetto di ispirazione delle più varie discipline artistiche? Considerando che spesso l’adulto la vede come un momento aureo dell’essere umano non-ancora-uomo, ne dobbiamo dedurre che ci sia un pessimismo di fondo che identifica la crescita con una inevitabile corruzione di sé?
La chiamerei piuttosto purezza. L’innocenza, che può presto mancare, è qualcosa che ha a che fare con le regole comportamentali, coi codici e con le leggi ed è tutta umana. La purezza viene invece dalle stelle. I bambini ne sono intrisi; forse è a questa, a questa dimensione cosmica dell’uomo, che fa riferimento la nostra nostalgia dell’infanzia. Poi si cresce e più si cresce più va perdendosi la materia delle galassie di cui siamo fatti. Ma non sempre è uno sperpero totale, in alcuni qualcosa si salva, si mantiene dentro di loro anche in età adulta. Sono esseri speciali, spesso inconsapevoli del dono che hanno conservato, individui che dovranno affrontare un mondo torbido, rozzo, di ignavi, un mondo che se ne frega della loro sensibilità e del loro profumo di stella.
Uno dei protagonisti del romanzo, Giuliano Arca, durante il viaggio alla ricerca del padre si porta sulle spalle una sedia: possiamo interpretare questa bizzarria come un invito al valore della ponderatezza in un periodo storico in cui la velocità (non quella costruttiva, ma più spesso quella figlia della superficialità) è la cifra dominante?
Credo che gli uomini abbiano perduto il legame col libero pensare. Intendo con lo spaziare del pensiero, col guardarsi intorno, col dedicarsi all’osservazione più pura della realtà per accorgersi una volta di più di quanto sia stupefacente il semplice stare al mondo. Per farlo occorre una sedia, occorre fermarsi, come il personaggio del mio libro, sedersi in mezzo a un campo o a una via o dove si creda. L’osservazione del mondo come momento centrale della propria esistenza. Respirare la condizione umana.
Fofi ha messo in evidenza una tua consonanza non solo stilistica con «il magistero femminile delle Morante, Ortese, Masino e Ramondino»: ci troviamo di fronte a una fratellanza letteraria da te cercata sotto forma di omaggio a queste scrittrici, o il tuo percorso di ricerca e di crescita come autore nasce indipendentemente da loro?
È sempre curioso ritrovarsi al centro del gioco degli accostamenti, ogni autore lo sa; scoprire che, del tutto inconsapevolmente, hai percorso le orme di quanti ti hanno preceduto nel cammino, prendere coscienza che per quanto tu ti senta portatore di una parola nuova non hai fatto che ripetere, a modo tuo, quanto altri avevano già detto e ridetto. Ma forse è proprio questa la magnifica ossessione, insistere a lavorare una pietra già perfetta, già modellata, vederla finita e inviolabile eppure martellarci sopra.
Hai avuto occasione di vedere i tuoi scritti tradotti all’estero (penso alla versione francese di Creaturine): considerando la tua “sapienza stilistica e affabulatoria” (cito dalla quarta di copertina di Alberi erranti e naufraghi) e la conseguente dovizia che persegui nella scelta delle parole, come valuti un tuo libro trasposto in un’altra lingua? Perde qualcosa, o è semplicemente un’opera differente? Come è andata la collaborazione con chi lo ha tradotto?
La collaborazione benissimo, sia sotto il profilo umano che sotto quello professionale. Per dare una valutazione corretta bisognerebbe però conoscere a fondo la lingua nella quale il testo viene tradotto. Senza la conoscenza di questa non è possibile alcun riscontro. Certo ritrovarsi tra le mani il prodotto finito può essere gratificante ma non è questo l’aspetto più interessante, bensì avere consapevolezza del fatto, ed accettarlo, che una persona altra esplori la tua opera tanto a fondo, la metta a nudo, entri nel tuo sistema mentale, metta piede in quelle stanze che tu credevi segrete. Ci si deve preparare dunque ad essere sviscerati e scavati, indagati, esposti. Chi opera, il traduttore, non ha altra strada, deve farlo per appropriarsi dei tuoi meccanismi linguistici ed è una scoperta per entrambi, autore e traduttore, o almeno così dovrebbe sempre essere.
Negli ultimi quindici anni tanti scrittori della Sardegna hanno avuto discreto successo in campo nazionale e internazionale, e sono anche nati dibattiti sull’utilizzo letterario della lingua sarda: ci sono alcune correnti di pensiero che sostengono che gli scrittori sardi che scrivono in italiano non possano essere considerati “letteratura sarda”: cosa ne pensi? Il tema della “limba” (e, eventualmente, dell’indipendentismo) suscita il tuo interesse?
Da sempre sono sardo e da sempre scrivo in italiano. Scrivo in italiano e non potrebbe essere diversamente vista la mia poca dimestichezza con la lingua sarda scritta; d’altro canto dove lo utilizzassi il mio sardo suonerebbe puramente strumentale, un espediente per allargare la cerchia dei lettori, un’operazione commerciale. Preferisco restarne fuori.
Creaturine è stato pubblicato anche in coedizione con Frassinelli, per cui hai avuto a che fare anche con un grosso gruppo editoriale, ovviamente diverso rispetto al mondo della media editoria indipendente de Il Maestrale: consiglieresti a un aspirante scrittore di iniziare (e magari restarci) con i piccoli editori prima di buttarsi tra le fauci dei grossi leviatani editoriali?
Davvero non saprei cosa rispondere. È una questione di fortuna. Si può capitare nelle mani giuste o sbagliate in qualsiasi momento. Posso però aggiungere una cosa: con la piccola o media casa editrice difficilmente vedi andar via il tuo titolo dal catalogo. È un modo discreto di trattare i titoli e le persone. Nel grande gruppo editoriale può avvenire l’esatto contrario; per esigenze di spazi, di programmazione o altro un titolo può andare in fretta al macero, e col titolo al macero ci vanno pure le persone.
I tuoi libri, come hai detto durante alcune presentazioni, nascono scritti a mano su comuni quaderni: c’è un motivo preciso per questa scelta, o è solo semplice abitudine? Pensi che scrivere direttamente su computer possa modificare il processo creativo?
Non c’è altro modo per me di scrivere che farlo a mano. Cerchiare le parole con penne di vari colori, cancellarle di netto, sottolineare alcune frasi, disegnare frecce di rimando e tanto altro fa parte della mia idea organizzata di scrittura. Con la scrittura a mano ho la possibilità, ritornando indietro nelle pagine, di rivedere i miei dubbi, la parola scritta, poi cancellata, poi riabilitata, un lavoro di scavo, di testimonianza materiale del dubbio e dunque della scelta. Non solo: spesso il mio quaderno aperto è costellato di specchietti, di elenchi, di nomi, termini, verbi, dialoghi, versi, il tutto da controllare simultaneamente, suoni che girano contemporaneamente. È una proiezione visiva di estrema importanza, la mia mappa mentale sul quaderno.
Oggi quasi tutti hanno un profilo nei social network, per cui se prima si chiedeva a una persona “Perché usi Twitter?”, ora la domanda è: “Perché non usi Twitter?” Non ti piacciono per qualche particolare motivo (penso ai tanti scrittori per i quali Facebook e Twitter sono diventati parte del loro lavoro) o ti lasciano semplicemente indifferente? Tra l’altro il tuo caso dimostra che non sempre il marketing da social network la spunta, visto che senza utilizzarlo hai vinto un importante premio – basato sui voti del lettori, lo ricordiamo – come “Libro dell’anno di Fahrenheit”.
Non uso Facebook e non uso Twitter perché non sono adatti al mio modo di rapportarmi col mondo, tutto qua. Non sono affatto contrario al loro utilizzo ma non mi sento in consonanza con un mezzo che richiede tempo e applicazione, non saprei come gestirlo se non in maniera discontinua e del tutto casuale. Per alcuni versi lo sento come un limite, perché dietro c’è qualcosa di affascinante, mi riferisco alla scienza e al miracolo tecnologico. A questo aggiungo una cosa: il premio di Fahrenheit è passato da lì, il passaparola ha viaggiato là; io non uso Facebook ma molti su Facebook si sono mossi per mio conto. E li ringrazio ancora.
Ti ringraziamo per la disponibilità, e attendiamo il prossimo romanzo.
Intervista a cura di Piero Fadda