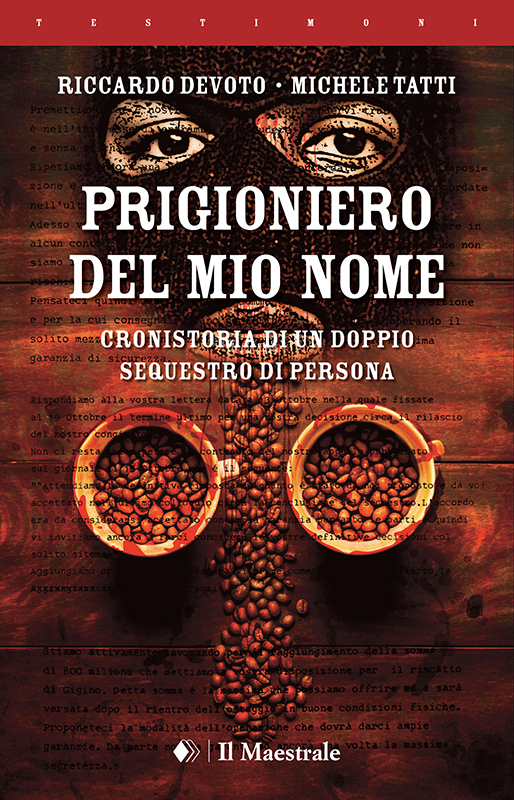«Fanno ormai cinquanta anni che vidi per la prima volta l’Isola dei Sardi. (Così, invece che col suo nome corrente, l’Ulisse dantesco indicò la Sardegna nel racconto del suo folle volo)».
Questo è l’incipit della premessa al libro <i>All’isola dei Sardi</i> fresco di stampa (ma si tratta di una raccolta di saggi per festeggiare un cinquantenario personale, usciti tra il 1956 e il 2006), che l’editore Il Maestrale presenta al pubblico non solo specialistico del grande etnografo Alberto Mario Cirese, docente di Antropologia culturale dal 1956 al 1971 all’Università di Cagliari, poi di Siena (1971-1973) e successivamente di Roma (1973-1992).
La riproposta di queste pagine deve considerarsi particolarmente propizia nell’attuale momento della vita culturale isolana, in cui certi temi capitali quali l’identità, l’etnia, la specialità regionale, la stessa idea nazionalitaria sembrano piegati nella vulgata corrente ad una formula strumentale e riduttiva, tutta circoscritta in se stessa a dispetto delle opposte dichiarazioni di principio, che evocano dialogo e apertura. Una formula che tende a restringere piuttosto che allargare lo spettro della realtà storica e che per colmo di paradosso viene invece da molti salutata come cifra della riappropriazione del “filo rosso” dell’autonomia.
Rileggere la lezioni di Cirese, specie del Cirese degli anni cagliaritani, sarà dunque un utile correttivo topico a certe distrazioni e semplificazioni ideologiche, che vengono ormai propagandate come oro colato della ritrovata genuina sardità.
Gli anni Cinquanta e seguenti furono anni di buona semina, fertili di ricerca delle implicazioni storiche delle cosiddette “radici”. Allora in Sardegna si visse un’intensa stagione di grande confronto tra le intelligenze interne ed esterne e la realtà isolana. Alcuni tra i maggiori studiosi italiani, tra cui appunto il Cirese, il Bianchi Bandinelli, il De Martino, il Petronio, il Maltese (per citare solo qualche nome), chiamati a insegnare nelle università sarde, a contatto col mondo appartato della nostra regione, applicarono generosamente le loro indagini alla storia locale e alle sue testimonianze, scoprendo sempre più insospettate parentele tra l’Isola e la Penisola anzitutto, e poi più in generale tra l’Isola e le culture del Mediterraneo.
Quella stagione segnò davvero, per dirla con le parole di Cirese, «il “recupero” della Sardegna alla storia europea». Un recupero che era iniziato in qualche misura già nell’Ottocento.
Si ruppe così l’incantesimo del mito, il sortilegio dell’autoctonia, la fascinazione del primitivo. Si indicarono e illustrarono i rapporti, gli intrecci, i depositi e i lasciti del passato, la nostra eredità: alla luce delle concrete risultanze storiche e non più di una supposta, quanto romantica, idea di “natura”. Superando così definitivamente quell’impasse delle “due classi” in cui si dividevano tradizionalmente gli osservatori delle cose sarde: quella dei “panegiristi” e quella dei “detrattori”.
Questo significava vedere in maniera più veridica le peculiarità straordinarie della Sardegna in quanto “zona conservativa”, proprio perché “meno esposta alle comunicazioni” epperò non “immobile”. Dove dunque l’”arcaicità” non aveva più nulla di mitico e autoctono, non appariva frutto di “anima” o “etnos”, bensì “risultato di una vicenda storica” solo più vischiosa che in altre aree dell’Europa.
Era la “smentita” definitiva a “ogni pretesa assolutezza sia dell’isolamento che della conservazione”.
È pur vero che quell’”assolutezza”, “smentita” e confutata nelle analisi storiche di Cirese e di altri maestri del Novecento, rispuntava nell’Isola in molti casi attraverso strane ma non inopinabili metamorfosi. Camuffandosi ad esempio sotto le specie della teoria del “filo rosso” dell’autonomia.
E questo è precisamente il motivo per cui sarebbe oggi da auspicarsi davvero un sistematico “ritorno ai testi” originali di simili maestri. Per fugare o smascherare le provocazioni locali di chi nell’Isola continua a confondere ingenuamente o in malafede le relazioni e intermediazioni storiche tra dominati e dominanti magari con un’opera nefanda da “collaborazionisti” o “canes de isterzu”.
Fare storia locale con spirito non localistico: questa è stata la grande lezione che ancora dobbiamo assimilare di quegli autori oggi non poco trascurati o dimenticati o snobbati da parte di certi novissimi predicatori di microstoria “alternativa”.
Un aspetto ad esempio che certi dottrinari del “filo rosso” tendono a mettere tra parentesi è la accentuata “differenziazione presente all’interno stesso della Sardegna”, sulla cui importanza insiste viceversa a più riprese, fra gli altri, Cirese.
Una “differenziazione” che certo ai “nazionalisti” o “etnicisti” sardi non piace riconoscere. Differenziazione d’impronta culturale e dialettale, spia inconfondibile di una vicenda storica più articolata e movimentata di quanto presumano o siano disposti ad ammettere i “regional-fusionisti” e “tradizional-autoctonisti”.
Non per questo Cirese si nascondeva un fondamentale carattere della realtà antropologico-culturale sarda. E cioè che la propria “differenziazione interna” non negava ipso facto la propria contestuale “differenziazione verso l’esterno”, e dunque in qualche misura la propria relativa “unitarietà interna”: quale la stessa qualificazione forte del termine “sardo” del resto comporta e comprova.
Cirese insomma accoglieva in qualche misura la «concezione di una “nazionalità” verticale cioè scavalcante le distinzioni di classe (vale a dire superante il livello del folklore, cioè dei dislivelli interni di cultura tra gruppi egemonici e gruppi subalterni), rivestendo così una qualche valenza “nazional-regionale”». Che però, si badi bene, lo stesso Cirese considerava un “atteggiamento soggettivo”, sia pur non disgiunto da “buone ragioni oggettive”, “coniugato ormai tendenzialmente al passato”.
Oggi invece si tenta di renderlo presente e futuribile. Si pretende di somministrarlo “pedagogicamente” alle nuove generazioni. Accoppiando magari ex abrupto il locale al globale: scavalcando e rifiutando cioè la mediazione e la sintesi da parte di una più ampia comunità nazionale, rappresentata dalla cultura dell’intero Paese oltre che dal senso dello stato (italiano: è appena il caso di sottolinearlo) nelle sue articolazioni non periferiche.
“Affrontare le tradizioni sarde come fatti storici”. Sembra un assunto assolutamente evidente e di piena semplicità. Eppure tutto il “difficoltoso” succo della lezione di antropologi culturali della stoffa di Cirese consiste esattamente in ciò. La difficoltà in questione ha per nome perlopiù certa resistenza locale a riconoscere come propria parte integrante e coessenziale un significativo prestito o un’influenza, un retaggio esterno: insomma, un apporto extra-isolano.
Ma Cirese non si nasconde i nodi più inquietanti della ricerca etnografica: «Il problema più arduo e complesso resta però quello di stabilire razionalmente se e in che cosa trovi oggettivo fondamento l’impressione di peculiarità che i fatti tradizionali sardi suscitano anche quando se ne conoscano i riscontri esterni e le variazioni interne».
È il problema capitale del “senso” delle tradizioni sarde. Ma attenzione. Proprio «qui, come è ovvio, si fa gravissimo il rischio del mito e della mistificazione»,
Il compito del vero antropologo è quello di individuare, dentro le costanti, le varianti che determinano appunto il senso della “specializzazione culturale”. Mantenendo peraltro sempre vigile la coscienza della sostanziale e preliminare distinzione tra “classismo” ed “etnicismo”.
Semmai quello che si può osservare nel pensiero di Cirese è talvolta una perplessità problematica, quasi un dubbio doloroso circa i confini delle due polarità. Che però la grande onestà intellettuale dello studioso scompone rigorosamente, non dissolvendole mai nella confusione tattica.
Diversamente da quanto è accaduto e accade purtroppo nell’esperienza di certi scenari attuali.