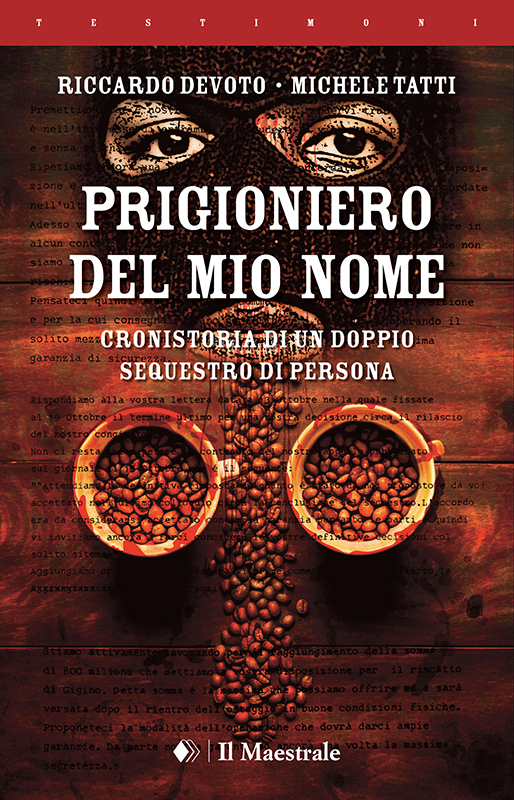Ci racconta di passaggio Gustave Flaubert in una pagina del suo Voyage en Egypte che i Franchi, gli antichi barbari, andavano assai fieri della propria superiorità sugli Arabi: per il fatto che essi bevevano l’acquavite, mentre i mussulmani no. Chissà se pure i Sardi barbaricini (quelli che, tanto per intendersi, “S’omine chi no buffada, no est omine” [nota dell’editore: “L’uomo che non beve, non è uomo”]), da sempre arciconvinti di essere i legittimi eredi della stirpe nuragica, non siano magari a loro insaouta i discendenti di qualche colonia peregrina di Franchi, sbarcati nell’isola per errore.
Questa curiosa premessa, per sottolineare che nella narrativa di Sardegna – sia in lingua italiana che in limba [nota dell’editore: “limba” in sardo ‘lingua’, ‘la lingua sarda’] – le cosiddette “zone interne”, alias “barbariche”, l’hanno sempre fatta da padrone, di riffa o di raffa. Hanno dunque fatto la parte del leone: perfino con Sergio Atzeni, il “metropolitano”, quando passava sulla terra leggero, a caccia di narratori di saghe indigene. Né potreste dir da meno di Marcello Fois, vicario foraneo di cesellature barbaricine, dalle verdi penombre dei colli bolognesi.
E ciò non a caso. Poiché una concertazione archeologico-antropologica e una consacrazione nazionalitaria hanno voluto identificare nella “zona resistente” la “culla delle radici”: la culla e la tomba, l’altare e la mensa.
Ed ecco già, dallo splendido isolamento della sua “tana d’avorio”, Gavino Ledda riproporre ad ogni primavera in nome del grano e del suo seme, la teoria della “telluricità quadridimensionale”, “astrale” e “primigenia”: cioè “muflonesca”. Maniera “gainica” per significare ancora e sempre il cuore mitico della regione, l’isola nell’isola, il grembo delle madri, il bosco sacro (per quanto ormai compromesso dalla siccità e dagli incendi).
Ebbene, se qualcuno di noi a questo punto nutrisse ancora dei dubbi circa la permanenza di un simile “richiamo della foresta” nelle “matrie lettere”, potrà dissiparli definitivamente leggendo Il postino di Piracherfa di Salvatore Niffoi, il “barbaro” (Edizioni del Maestrale, Nuoro, 2000).
Il suo romanzo d’esordio, di qualche anno fa, s’intitolava Il viaggio degli inganni. Ed era la cruda, straordinaria autobiografia del sottosuolo di un barbaricino di fine millennio, nella cornice distante dell’ultimo mezzo secolo di storia italiana, ed isolana: dal piano di rinascita al mercato globale, passando per gli anni di piombo. Autobiografia che lasciava sgomento il lettore per la violenta se non anche lutulenta carica di realismo oggettivo al limite dell’atto dinamitardo, associata ad un virtuosismo abbacinante della metafora espressiva.
Ci è sembrato idoneo a suo tempo classificare questo stile come “gorgonico”. Il motivo? Perché quasi paralizzava la comune sensibilità estetica, con una calclata overdose di fascini emozionali; e anche perché affrontava, forse per la prima volta senza veli, la Medusa, ossia la buia viscera identitaria: osava cioè “mettere l’occhio dentro il cuore della propria terra” (per dirla con espressione testuale dello scrittore).
Probabilmente nessun altro scrittore sardo si era spinto a tal segno su questo terreno. Forse nemmeno il più dostoevskijano dei narratori isolano, Sergio Atzeni.
Ecco perché, con quella sua faccia da sofista luciferino o da sileno elettrico, temprata ai raggi del sole sardignolo, curiosa sovrimpressione del busto socratico di Sebastiano Satta sull’ovale mefistofelico di Pirandello, Salvatore Niffoi ci appare con le stigmate del vero “barbaro”, ancorché letteratissimo.
Insomma vogliamo dire che ci si presenta come un autentico icocervo: in cui ci pare di poter scorgere, tra le suppellettili di tzia Tatana, ora un pezzo di Gadda, o magari di de Andrade e Baudelaire, oppure di Cela e Majakovskij, e in definitiva di nessuno dei sei (a parte poi la spiazzante benché trasparente citazione letteraria che il titolo ci spara in copertina: Il postino di Piracherfa: dove all’ormai fatidico “postino” risulta questa volta affibbiato il genitivo “di Piracherfa”, anziché “di Neruda”).
Ci pare soltanto, però. Poiché in verità constatiamo che si tratta di un Niffoi purissimo, al cento per cento. Come per altro si ricava già dalla prima pagina del romanzo, quando noi leggiamo che “Il latrato dei cani si spalmava sui vetri delle case di Piracherfa come una maschera latteosa e urticante”.
Questo romanzo narra la storia di Melampu Camundu e di Piracherfa (attenzione all’onomastica di Niffoi: sempre minata da cifrari simbolici). Ebbene, Melampu è il “Postino” (no staremo qui a discettare se vi si nasconda l’indovino Melampo, antichissimo fondatore dei culti dionisiaci, oppure l’omonimo cane di Pinocchio). E “Piracherfa” cos’è? Piracherfa è la sua controfigura: dalla sagoma materna (o matrigna) di “pera acerba”. Altrimenti detto: “Piracherfa” è “Piracherfa”, e “Melampu” è il suo profeta.
“Piracherfa è un paese inchiodato ai piedi dell’altopiano di Locosu, che all’alba apre gli occhi spaventati sulla rupe di Burthulè e di notte li chiude sotto il peso di un buio catramoso che avolge case, bestie, uomini”.
I suoi abitanti non sono difformi da lei: anch’essi ectoplasmi della nullità del vivere, paradossalmente ingombranti dalla prpria corpulenza, che è simile al peccato originale.
E quando cala la notte attorno alla casa e al mondo di Melampu, a Piracherfa tutto sembra dissolversi nell’informe sbadiglio di una crepuscolarità infernale: “Le lampade a pera dalla finestra lasciavano filtrare una luce che mollemente ondeggiava sui vetri impolverati dell’armuà. Fuori, la nebbia albumosa e leggera bussava ad ogni porta, prima di sfilacciarsi tra i rovi del’altipiano”.
In immagini come queste voi sentite davvero i brividi del lirismo rimescolarsi dietro ai freni di una sprezzatura anti-idillica, per accordarsi infine, e insieme armonizzarsi, nell’ironica e tronca pennellata dialettale di quell’”armuà”.
State magari comprendendo che il gusto di Niffoi per una corporeità impastata d’incubo e di sogno potrebbe davvero definirsi “felliniano” di tipo truculento e proletario.
Tutta la poetica del narratore oranese scorre infatti dinanzi ai vostri occhi col suo carico di materiale onirico, in mezzo ai flutti di Scila e Cariddi, cioè tra brutalismo e tremendismo: come il film di un rusticano e stralunato “palio dei buffi” o dei “folli”, e magari dei “tristi”.
Si direbbe anzi che la sua scrittura venga elaborata come sotto i funi eccitanti dell’alcol, nel momento critico della lucidità paradossa. E allora ci ritorna alla mente il richiamo di Falubert e degli antichi Franchi,… dell’acquavite e dei suoi santi bevitori. Chissà! Magari Niffoi sarà addirittura astemio, ed è anzi l persona più sobria che potreste incontrare. Però la sua pagina ci “stravede” benissimo, “sragiona” che è una meraviglia.
E così, quando alla fine del romanzo e della storia, e al termine di una vita eccessiva e piatta come una sbornia infelice, Melampu precipita lentamente, fatalmente verso il manicomio criminale di Santa Barbara, egli ha cessato per sempre di lottare contro se stesso. Poiché ha “ucciso il male”,… ha “ucciso il male”.
Allora, “gonfio come un rospo” e “grasso come un porco”, egli è diventato simile ad “una macchia di colore che si spiaccica nel muro della piazza di Sa Udditta”. Ridotto ormai alla fredda condizione del minerale, solo adesso può ritornare, dopo il buio fracasso del folle shakeseariano che non significa nulla, alla natura assoluta degli elementi: da dove era stato originato. Finalmente “i suoi pensieri possono perdersi e spargersi come le pietre che dormono sotto le radici del mirto”.