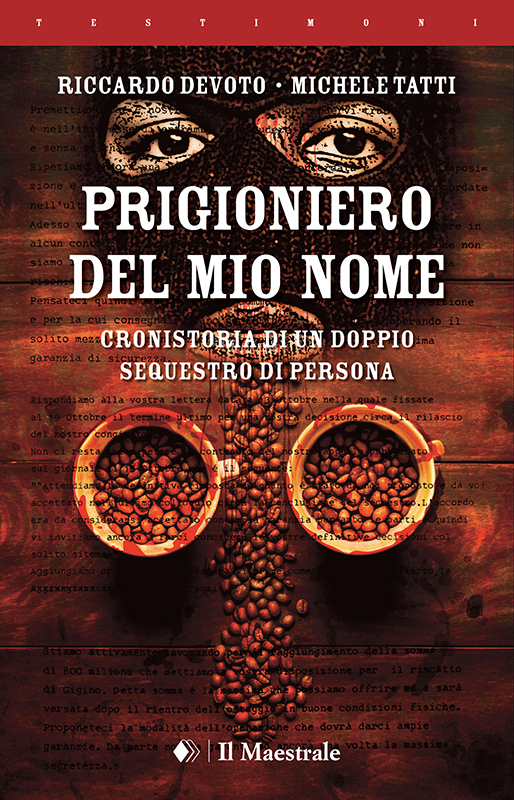«Creaturine» (Il Maestrale, 2004) è il titolo fanciullescamente lieve e diminutivo di un romanzo soavemente crudele di Alberto Capitta, autore di origine sassarese alla sua seconda fatica narrativa.
La vicenda è ambientata in un frammento di mondo, nella provincia astratta se non irreale di un Ottocento imprecisato e incongruente, dentro una Sardegna dalla geografia inverosimile o irriconoscibile eppure non mistificatoria, dove si è persa o non è mai esistita traccia di una tangibile differenza fra città e campagna, fra spazio urbano e ambiente naturale. Uno strano lembo o meglio limbo di terra.
La storia è una storia in miniatura, amara e insieme ebbra di amore e di dolore, una storia dall’apparenza ingenuamente insensata o incantata. E’, in poche parole, la parabola allegorico-esistenziale di due amici orfani, e di altre maschere e dramatis personae, attraverso l’itinerante caravanserraglio di simboliche «creaturine»: le «figurine» dell’umano destino.
Due amici orfani, i quali sembrano i due volti, le due anime simmetriche di una comune identità: quella diurna e quella notturna. O - se preferite - la realtà e il sogno, il quotidiano e l’avventura, la civiltà e la natura. In definitiva, il mistero ambivalente della vita. Curioso e insolito è l’incipit di questo romanzo, rispetto alla tradizione scenografica della narrativa sarda del nostro tempo. Curioso e insolito, con quella sua ambientazione abrupta dentro un paesaggio acquatico e palustre - nella fattispecie, l’ambiente della laguna cagliaritana - con quel suo stravagante richiamo, d’impronta riflessa fra le drammatiche circonvoluzioni della fabula e dell’intreccio, a certa imagerie ottocentesca relativa a mitiche spedizioni geografiche e ornitologiche, o alla figura dello stesso Alberto La Marmora, che ci pare di intravedere nell’ironica raffigurazione di un antico disegno che lo ritrae apparecchiato di tutto punto nella veste dell’esploratore e dello scienziato naturalista.
Singolare anche lo stile, per certo verso così fiammingo, lenticolare della pagina di Capitta, con quella sua impaginazione razionalmente controllata e tendenzialmente impeccabile, ma dalle impreviste increspature concettose, micro-licenze barocche e vigili sbavature surreali, quasi un intermittente, divergente espressionismo sotto traccia, di metafore abnormi: «Nicola è di una bellezza di spine, che fa sanguinare gli sguardi e voltare gli alberi».
La scrittura del nostro autore è a suo modo innocentemente perfida. Nel bel mezzo dell’immagine signorile, chiara e distinta, s’introduce talvolta di soppiatto una nota dissonante, una flessione di registro, una deviazione stilistica plebea, oscena quanto basta, e sempre e comunque di testa. C’è insomma tutto il gusto della frase ritmica ben costruita e costumata, ma dotata di uno sporadico quanto straniante effetto di spiazzamento.
Immergersi nella scrittura di Capitta è un po’ come trascorrere, lungo un’ipotetica linea di sviluppo dello stile narrativo riferita alla Sardegna contemporanea; è un po’ come trascorrere - dicevamo - dall’arte romanica o gotica alla pittura manieristica. La cifra letteraria di questa scrittura è la qualità più interessante dell’operazione narrativa di Capitta, la quale secerne una sostanza di racconto che potremmo definire a tendenza frammentistica e aforistica: attraverso uno stile che accoppia in qualche maniera e combina la struttura razionale con l’impulso metaforico, l’impaginazione logico-sintattica con il gesto surreale e a tratti perfino con la scrittura automatica.
Dal punto di vista poi della messa a punto del procedimento di metaforizzazione, Capitta mostra ad esempio alcune significative affinità o parallelismi formali rispetto a Giorgio Todde, una delle vedette del romanzo sardo contemporaneo, quel Todde che peraltro si distanzia dal più giovane collega per gli aspetti tematici e semantici. Nel senso che Todde aveva qualche anno fa già sperimentato e introdotto un metodo di elaborazione originale della metafora, basato nella fattispecie sulla combinazione algebrica del linguaggio tecnico-scientifico con la percezione visiva, olfattiva, uditiva, gustativa, tattile della realtà quotidiana, mirata con penetrazione psicologica. Ebbene, in Capitta tale meccanismo si mette in moto in maniera non molto dissimile, anzi possibilmente più continuativa e prolungata, benché assai meno tributaria rispetto agli stimoli dialettici del linguaggio delle scienze; vale a dire in maniera forse più incline alla creatività di un «esprit de finesse» che a quella di un «esprit de géometrie», se così si può dire.
Per altro verso, abbiamo qui a che fare con uno stile di racconto dalla procedura avvolgente e labirintica, grammaticalmente perfezionistico quanto minimalistico, ma poi decisamente massimalista in ordine all’orizzonte intellettuale sottostante, giacché col romanzo di Capitta ci troviamo a ben vedere di fronte a un testo in cui si cela una profonda religiosità; uno stile che in qualche modo - a voler proseguire nel gioco degli accostamenti e delle eventuali parentele - potrebbe ricordare certo gusto o taglio narrativo prediletto da Salvatore Mannuzzu. Parallelo ma non coincidente, d’altra parte, anzi proprio contrapposto all’esempio di cui ci occupiamo, benché ad esso equiparabile per intensità e potenzialità creativa, il procedimento di proliferazione della metafora privilegiato viceversa da Salvatore Niffoi, di tipo questa volta etno-realistico-espressionista. Un procedimento assai differente da quello di Capitta per taglio semantico e dinamico, fondandosi il nostro autore di preferenza su procedimenti di immaginazione di tipo psicologico-sentimentale e l’altro viceversa sulla matericità e carnalità, sul linguaggio pastoso del corpo. Un linguaggio del tutto difforme da quello della creaturalità evanescente tipico, giustappunto, dell’artefice di «Creaturine».
Ma state a sentire uno scampolo dello stile di Capitta: «La sua vita immaginaria era rimasta ad osservarlo dalla sedia. Egli pure si voltò a guardarla, si voltò per istinto, per un istinto che non sapeva di avere, e si osservarono, restarono a fissarsi per pochi secondi, poi la sedia si allontanò navigando da sola verso le terre dove la vita è tutta da fare e nulla ancora esiste». Oppure quest’altro. «La donna non era bella. Troppo grossa di fianchi, troppo celeste nei suoi occhi, ma quelle natiche nuvolose avevano la morbidezza delle gardenie fresche... avevano il fascino di un sito archeologico alla cui scoperta egli andava, sorvolando l’aria come un giovane aliante perdutosi nel deserto».
In conclusione: la narrativa attuale in Sardegna sembra decisamente uscita da quell’impasse, da quel relativo stallo di una sia pur qualificata monotonia dall’accento austeramente monocorde che ancora caratterizzava gli anni che ci stanno immediatamente alle spalle. Da Angioni a Fois, da Niffoi a Soriga, da Todde a Capitta, dalla Clarkson all’Alcioni (per tacere di altre pur interessanti presenze) lo spettro, la gamma delle soluzioni stilistiche e narrative a livello di officina locale si è coraggiosamente ampliata. Il romanzo fatto in Sardegna o comunque da autori sardi residenti oppure migranti ha compiuto ormai una vigorosa svolta, che oggi colloca questa forma di espressione letteraria munita di marchio isolano in una posizione paritetica, e per qualche aspetto addirittura emergente, rispetto all’attuale panorama federativo nazionale. Designando quest’ultimo alla maniera federalistica, adoperiamo una formula forse un po’ troppo «di moda», da risultare sospetta e non immune da equivoci, ma che probabilmente risponde anche a un fondo o istanza di verità nell’odierna realtà culturale del nostro Paese. Nello specchio peraltro sempre vivo della letteratura italiana. Anzi - come a taluno più piace, e come più si confà del resto al gusto denominativo plurale di una «federazione» - nel quadro sempre aperto «della letteratura degli italiani».