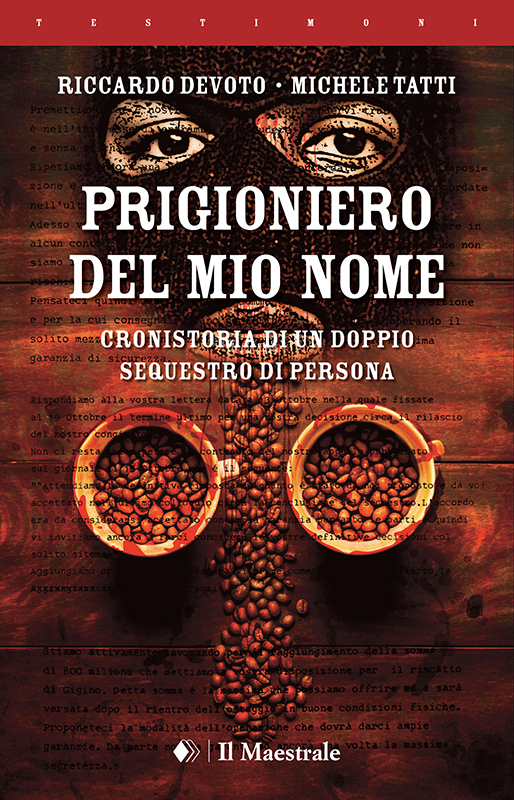Carmine Abate, come i suoi numerosi lettori ben sanno, è soprattutto narratore. Un narratore i cui romanzi – a partire da Il ballo tondo, La moto di Scanderbeg, Tra due mari, su su fino a Il mosaico del tempo grande e Gli anni veloci – usciti tutti per Mondadori e tradotti in varie lingue, hanno ottenuto un crescente successo di pubblico e di critica sia in Italia che all’estero. Meno noto è forse il fatto che egli ha esordito nel 1977 con un volumetto di versi, Nel labirinto della vita, cui sono seguite nel 1992 due agili plaquette, Di noi e Dimore, poi confluite insieme a nuovi componimenti nell’antologia Terre di andata, apparsa nel 1996. Si tratta dunque di testi composti nell’arco di un ventennio e che pubblicati in tirature limitate presso piccole case editrici risultano, ormai da tempo, introvabili. Le Edizioni Il Maestrale di Nuoro, hanno ora colmato tale vacanza allestendo un nitido e denso volume, “Terre di andata”, che è approdato proprio recentemente nelle librerie.
Qui Abate, pur conservando la stessa intestazione della silloge edita nel 1996, ha operato alcuni cambiamenti (qualche taglio, lievi ritocchi, una diversa disposizione di certi testi, l’aggiunta di una quindicina di poesie) che ci consegnano un libro che oltre a mostrare una sua precisa nonché forte fisionomia, sembra anche aperto a future integrazioni. A cominciare dal titolo, sintesi stringente e aperta metafora di una condizione esistenziale segnata dalla provvisorietà, dall’erranza, dall’inquieto cercare, fino alle quattro sezioni in cui si articola, tutte strettamente legate alla parola – chiave “dimore”, che ne ribadisce, rafforzandola ulteriormente, la pregnanza. Così già sulla soglia della sezione inaugurale, “Dimore tra me”, incontriamo uno dei temi dominanti dell’intera opera di Carmine Abate, l’emigrazione. Né potrebbe essere diversamente perché esso, come sa chiunque abbia appena un po’ di dimestichezza con i suoi testi, prima di diventare motivo ispiratore della sua attività creativa è stata un’ esperienza dura e drammatica della sua gente (le comunità albanesi dell’Italia meridionale), della sua famiglia e infine anche personale. Talché affermare che egli, come scrittore, è nato da quella esperienza, non è per nulla azzardato. Lo dimostra, ex professo, proprio questa raccolta in cui Abate ha sentito l’urgenza di affidarsi all’essenzialità della parola poetica per trattare la medesima dolente materia oggetto di due opere coeve: gli straordinari racconti del suo esordio narrativo Den Koffer und weg!, usciti in Germania nel 1984 (poi in italiano con il titolo Il muro dei muri nel 1993 e nel 2006) e l’importantissima inchiesta storico-antropologica “I Germanesi” (pubblicata in tedesco nel 1984, poi in italiano nel 1986 e nel 2006). Ma fermarsi a segnalare questa ricorrenza tematica in Abate è un’annotazione poco meno che superficiale (è lo stesso che dire – tanto per fare un esempio chiaro – che il leitmotiv di Fenoglio è la Resistenza), se non ci si dispone, illico et immediate, a capire cosa è diventato quel tema nelle mani di chi come lui, mediante le raffigurazioni dell’esilio, dell’emigrazione, dello spaesamento, del ritorno, ne ha fatto una sintesi creativamente altissima “dell’identità mobile dell’uomo contemporaneo che, attraverso l’incontro con l’altro, scopre di appartenere a più culture, di essere un rizoma in cui l’ibrido è fonte di vita, di abitare la differenza” (A. Luzi). Orbene di questo forte itinerario tematico le poesie di “Terre di andata” rappresentano una tappa iniziale molto significativa. Per rendersene conto basta anche una semplice scorsa al libro. I testi si susseguono compatti facendo emergere fin dai versi pre-liminari (“Alla fine”) una voce poetante che animata da una netta radicalità civile e morale indaga tutti gli aspetti o, meglio, le ferite della condizione immigrata. Dall’esclusione (compare la parola ghetto a indicare i luoghi dove abitano gli emigrati) alla lontananza che mette a dura prova persino gli affetti (“come si fa a volersi bene / se si sta così lontani?”); dai morsi della heimweh a quelli della fremde (“Fremde è estraneità / estero spaesamento / altrove che in arbëresh / non saprei come tradurre / nel carcere del vento”); dalla solitudine all’impossibilità di una vera integrazione (“Mi rubo queste sere bagnate / rattrappito in vuote poltrone / e non trovo dimore / principesse travestite da rane / ma ubicazioni e zioni e zioni / ideali e calore fittizio”); dal razzismo affiorante dalle scritte sui muri o dai manifesti (si veda “Altona City” a pag. 43) a quello che nutrendosi ancora dell’orrore storico torna a farsi minaccioso nella vita quotidiana (“Na ja. È successo che ora gridano: / Ausländer raus! Na ja. / È successo anche allora”). In diversi testi dunque, come è facile desumere anche da questo rapido specimen, prevale ora un tono di rabbia ora un tono di amara disillusione. Ciò accade perché negli anni in cui sono stati scritti, Abate era mosso prevalentemente da una volontà di denuncia della costrizione ad emigrare e insieme dalla piena coscienza dell’inadeguatezza, della vacuità, della fallacia di tanti rituali discorsi sull’emigrazione.
Di qui allora anche il rifiuto, sul piano oggettivo, delle parole cosiddette autorevoli ( “ Oh, le teorie della società/ dell’economia dello stato. Anche in Marx./ In Marx e Weber. Nessuno s’arrabbia / tutti d’accordo. Si parla di teorie./ E fuori mio padre respira catrame/ asfalta le strade nella patria Weber/ di Marx[…]”) e, su quello soggettivo, delle parole estetizzanti sia dell’arcadia che dell’avanguardia : “ Liberami dalle verzure infine/ e dai cieli cilestrini macchiati di/ rosso dalle lotte secondarie chiuse/ nei cassetti […] e liberami ti prego/ dalla bolgia purulenta di parole / dell’avanguardista di professione”. Insomma la parola come luogo dove non si può né si deve barare. Così la poesia di Abate, esattamente come la sua narrativa, pur prendendo sempre l’aire da una dimensione autobiografica, testimonia fin dall’inizio di una condizione collettiva (si noti la continua alternanza dell’”io” e del “noi”) e rivela la sua natura autenticamente sociale.
Ma è ancora qui, nelle pagine di queste “Terre di andata”, che si trovano – aldilà della rabbia e dell’amarezza di fondo – i primi passi sicuri di quel cammino che ha condotto Abate all’esito più alto della sua weltanshauung artistico-esistenziale che egli chiama “vivere per addizione”. E cioè la piena consapevolezza che l’incontro tra le culture, la reciproca conoscenza e lo scambio possono essere vissuti come un arricchimento personale e una comune speranza da realizzare. In tal senso vanno letti i versi qui di fianco riprodotti e tutta l’ultima sezione della raccolta, dove l’anima raminga dell’io-poetante trova finalmente una sua certa dimora nell’amore per una donna, figlia proprio di quella terra di andata che è stata la meta principale, agognata – rifiutata, dei migranti.
Un discorso a parte – che non ho più spazio per fare – meriterebbe infine la lingua poetica di Abate. Mi limito allora a dire che essa possiede una dote abbastanza rara: è nata, è cresciuta e sta in piedi da sé. Non ha avuto bisogno di punti di riferimento né di alcun magistero, ed è per questo che ha una sua identità originale fuori da ogni scuola e moda, che ne garantisce le potenzialità e la durata.