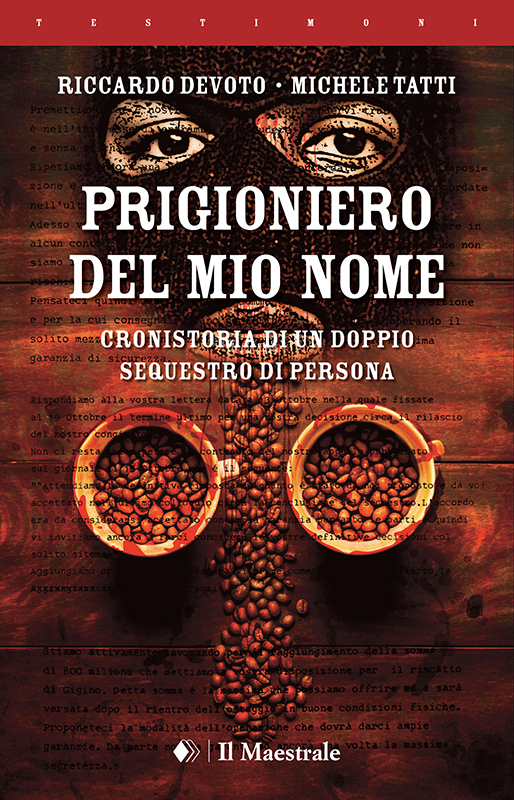«Questo paese è noto per i vini fermi, e per un’ospitalità che dispensa pecorino, salumi tagliati a coltello e arrosti maniacali». Il narratore di A tie solu bramo, romanzo di Giulio Neri edito da Il Maestrale, si serve del richiamo a un’immagine stereotipata della Sardegna turistica come introduzione alla storia che si accinge a raccontare. L’efficace strategia dell’incipit, che induce il lettore a credere che percorrerà strade note e già letterariamente battute, è rafforzata da un titolo che accarezza il senso profondo dell’identità sarda. Tratto dalla canzone Non potho reposare, il verso completa un processo di riconoscimento che chi tesse le trame del racconto si adopererà invece abilmente a smantellare. La narrazione, andando oltre ristretti confini, si farà infatti strumento per leggere il mondo e le guerre di civiltà che lo attraversano. Indagherà inoltre l’animo umano. A tie solu bramo non è quindi un romanzo sulla Sardegna, luogo da cui la storia procede e fa frequente ritorno. Il libro, seconda prova di Neri dopo Carta forbice sasso, insiste soprattutto sul conflitto vita-morte, tema caro a Céline in Morte a credito. Insinua, dove il nichilismo sembra trionfare, la forza risorgente dell’amore o il languore della sua assenza. In questa prospettiva Non potho reposare supera l’occasione antica della composizione e si propone come «canto remoto di un’attesa dietro la natura che sembra dormire e invece veglia nell’oscurità con animali acquattati che bramano, patiscono e muoiono».
Il lettore ne percepisce il valore universale perché quella melodia s’innalza in un contesto straniante: è voce intima di Clelia Boero. Cinquantenne torinese, vestita di un «eskimo stinto» che testimonia le rivoluzioni per cui ha combattuto, è protagonista della storia, centro di un romanzo corale che ha come prima quinta il paese del Sud Sardegna da lei scelto per un misterioso soggiorno. La sua venuta, enfatizzata dalla contiguità con «la locanda covo di senegalesi, pelandroni gurgugnao mantenuti dall’Unione europea», produce reazioni di sospetto. Fa scattare l’atteggiamento di pregiudizio che la comunità oppone a chi percepisca come estraneo, ancorché non straniero. Orlando, figlio dell’egiziano Mahfuz «il Beduino» e de «Sa bagassa de bidda», è nato all’ombra di quello stigma. Fulcro di incroci tormentati tra Oriente e Occidente, è anatomopatologo lucido davanti all’interpretazione della morte. Incerto – al pari degli altri personaggi del romanzo – di fronte al più arduo compito di leggere la vita.
27 ott 2018 - L'Unione Sarda | Manuela Arca