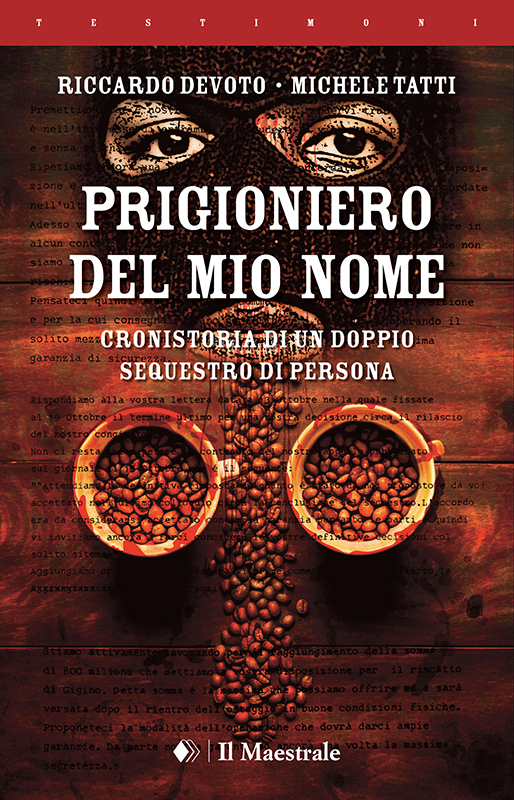Alba lavora di notte, da anni, al laboratorio del Dipartimento di Genetica della sua città. Ha solo sette anni e otto mesi più di Carlo e Valentina, i due gemelli cui ha fatto praticamente da madre, da quando i genitori non ci sono più. Quando la incontriamo, Alba sta già vivendo i suoi «giorni bui»: ha scoperto che Carlo − più precisamente: è stata Valentina a darle la possibilità di capirlo − , il fratellino bellissimo, è tossicodipendente, e che, da «allegro, entusiasta, vanitoso […] il fiore di noi Pistis», è diventato un ragazzo «duro, irridente, maligno». Alba, che racconta in prima persona la dolorosa vicenda, lo ammette dall’inizio: è accaduto qualcosa che vedeva ma che non sapeva di vedere, e forse voleva ignorare. Giulio Angioni pare volerci inchiodare subito a una domanda fondamentale: chi sono gli altri? Quelli che crediamo di conoscere perché ci vivono accanto, perché sono cresciuti o invecchiati insieme a noi, e che sono addirittura i nostri stessi familiari? Una domanda che mi piace riformulare attraverso due splendidi versi di Evtuscenko: So come sei con me. / Di là da quella soglia, come sei?
Stia attento il lettore a non confinare questo romanzo entro limiti, per così dire, di pirandellismo. Pirandello resta lontano. E Angioni si conferma scrittore di formidabile qualità antropologica (poco importa, poi, che faccia anche l’antropologo di professione): sicché noi ci accorgiamo subito che la domanda decisiva è un’altra, pur discendendo direttamente dalla prima. Questa: che cos’è la famiglia, e che cosa può accadere veramente al suo interno, là dove le verità s’impongono con il linguaggio eloquente della reticenza? Le epigrafi che fungono da soglia a un romanzo possono essere illuminanti, soprattutto quando sono scelte con intelligenza critica. Angioni non poteva essere più chiaro, ricavandola da una citazione di Karl Kraus, svagata eppure terribile: «Spesso però anche la somiglianza tra padri e figli ha le più tragiche conseguenze». Pirandello resta lontano: anche se, quanto a ossessioni familistiche, la Sardegna di Angioni può valere come quella Sicilia. Intendiamoci: io non credo che, in letteratura, la geografia sia mai risolutiva: epperò qualcosa vorrà dire che Alba dei giorni bui sia stata concepita su quell’isola la cui cultura resta sensibilissima al problema identitario, ai processi profondi che l’identità strutturano. L’isola in cui il passato non finisce mai di passare: per romanzi in cui − da Satta a Mannuzzu − i morti si mescolano ancora ai vivi, e talvolta con più invadenza.
Perché dico questo? Per il fatto che anche quella di Angioni − ce ne eravamo già accorti recensendo qui La casa della palma (2003) − è una famiglia allargata: ai trapassati, che non trapassano mai. Nella lingua di Alba, dove la visione ha la stessa nitida consistenza della realtà, la tossicodipendenza di Carlo si va a sovrapporre subito al diabete del padre: «Carlo e babbo, babbo e Carlo… continuo a confondere i loro due mali, tutti e due appesi a una siringa». La famiglia: eterno ritorno del rimosso. La famiglia: che è sempre oscuro avvertimento di un trauma, d’una colpa e d’un rimorso. Su una strada che, dalla Deledda a Mannuzzu, ha dato risultati anche alti. Angioni conosce bene quella strada: e sa anche come incamminarvisi.