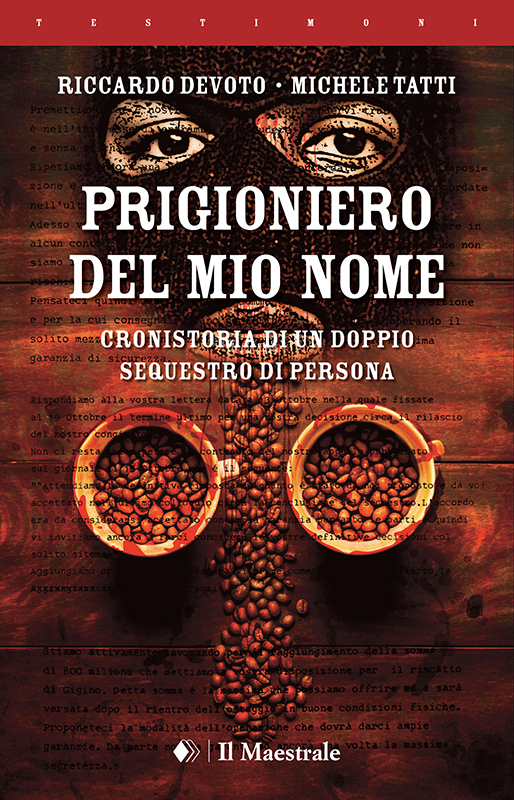È un epicedio a una Sardegna scomparsa quello che Giulio Angioni leva nel Gioco del mondo, la rievocazione un po' nostalgica di una società agropastorale in gran parte scomparsa, e di cui sembra a rischio la stessa memoria. Non c'è, in questa operazione di recupero di un passato allo stesso tempo prossimo e remoto, nessuna idealizzazione, nessun edulcoramento retrospettivo. Quel tanto di vagheggiamento a ritroso che si trova in queste pagine, l'autore ne è ben consapevole, è soltanto quello "fisiologico" di ogni ritorno al passato, di ogni ricordare che, come abbiamo imparato leggendo Leopardi, di per sé è dolce e piacevole. Anche l'esperienza atroce della prima guerra mondiale, con lo squallore delle trincee, con la paura e le privazioni, diventa, per i vecchi che a distanza di decenni la rievocano seduti al sole sul muretto del paese, qualcosa di bello e degno di rimpianto; osserva il narratore: quell'esperienza coincide con la giovinezza, nulla di strano che anch'essa sia guardata con nostalgia. E così è un po' per tutto il mondo rievocato in questo libro. E' un mondo che il narratore solo in parte ha conosciuto direttamente, da bambino. In un certo senso è un mondo senza tempo, di cui si ha notizia attraverso la memoria comune, tramandata di padre in figlio, di comare in comare, attraverso racconti, modi di dire e allusioni, diffusa ed elaborata secondo i tipici processi delle culture prevalentemente orali. Molti dei personaggi che affollano queste pagine, che animano queste storie, sono personaggi la cui esistenza sarebbe benissimo collocabile in un'epoca molto più lontana di quella in cui verosimilmente hanno vissuto. Il fatto è che essi appartengono per lo più a un mondo in cui i cambiamenti avvenivano a un ritmo molto più lento di quello cui siamo oggi abituati.
Il ritmo dominante il nostro mondo è tale che tutto ciò che esisteva prima della grande trasformazione risulta non solo molto difficile, ma addirittura quasi impossibile da pensare, da rappresentare senza una violenta distorsione.
Si corre il rischio di vedere solo barbarie e superstizione nelle pratiche di guarigione per imposizione delle mani attuata dalla vecchia tzia Desolina che, essendo inchiodata a letto da mille malattie, si faceva volentieri carico anche dei mali degli altri, fungendo così come una sorta di parafulmine per i suoi compaesani. Ancora più scandalo potrebbe destare l'uso rituale di cucire il culo delle tortore offerte alla Madonna delle Candele, perché non sporcassero il panno immacolato su cui stavano poggiate in occasione della solenne processione. E mille altre usanze e abitudini che, decontestualizzate, danno l'immagine di un mondo che appare solo strambo e bislacco. Angioni è ben conscio di questo pericolo, e accetta il rischio, ma si premura di sottoporre in partenza tutta la sua operazione di recupero a una violenta distorsione, che costringe a non fermarsi a una lettura superficiale ed episodica, e ad addentrarsi piuttosto in un tentativo di comprensione che passa attraverso una ricostruzione che è al tempo stesso una rielaborazione.
In altre sue opere narrative, romanzi e racconti, Angioni aveva scelto di calare la descrizione della Sardegna scomparsa, o meglio, di una Sardegna che deve fare i conti con una violenta e rapidissima metamorfosi, nelle strutture del romanzo giallo, dell'inchiesta (L'oro di Fraus, Il sale sulla ferita, e soprattutto Se ti è cara la vita, di cui Il gioco del mondo è quasi una riscrittura). Questa volta decide di fare un passo più avanti, di fare a meno di strutture in qualche modo esterne, e di puntare invece verso la purezza della rappresentazione poetica, verrebbe quasi fatto di dire verso l'essenzialità della lirica. Se già nelle sue precedenti prove appariva evidente l'importanza assegnata alla musica delle parole, a rime e ritmi che improntano le sue pagine di una cifra inconfondibile, nel Gioco del mondo la stessa struttura portante discende da un'opera poetica che ha segnato più di una generazione, l'Antologia di Spoon River. Edgar Lee Masters passava in rassegna le lapidi e le tombe del cimitero di un piccolo centro della provincia americana, disegnando in pochi, essenziali tratti la fisionomia di tante persone qualunque, morte giovani e vecchie, dopo le più varie esperienze di vita; pur mantenendo ciascuna la sua irriducibile particolarità, queste figure si rivelano però, nel rumoroso silenzio della collina cimiteriale, capaci di esprimere gioie e dolori, timidezze e audacie, ansie e speranze di portata universale.
La maggior parte dei personaggi di cui si fa storia nel Gioco del mondo sono morti. Spesso lo spunto per parlarne è direttamente la tomba, la breve epigrafe o la fotografia scolorita posta a salvaguardare un ultimo brandello di identità. Ma non sono solo i monumenti funebri a preservare il ricordo, a garantire una comunicazione tra il mondo dei morti, cioè il passato, e quello dei vivi. Anzi, non sono principalmente i monumenti funebri che assicurano la continuità di questo filo, di questa connessione. Molti morti non hanno avuto la fortuna di una sepoltura di pietra e fiori, come Flebas il Fenicio, il "morto per acqua" della Terra desolata di T.S. Eliot richiamato non certo a caso in una delle prime pagine. E' solo la memoria, la pietas dei compagni di avventura, di coloro che continuano ad affrontare le acque malcerte della vita, che garantisce una sorta di sopravvivenza. Ma soprattutto è la parola del poeta che è istituzionalmente deputata a questo compito.
E che cos'è la poesia se non un gioco, un gioco in cui, date certe regole, passibili peraltro di variazioni al tempo stesso arbitrarie e rigorose, nei ristretti limiti dei versi e delle strofe viene fatto rientrare il mondo? Così, il primo incontro, la prima "stazione" di questo pellegrinaggio della memoria, è quello tra il narratore e Pietro Massa, tra l'intellettuale che ha abbandonato il mondo dell'infanzia e della giovinezza e è ormai di casa nel grande mondo della città, e il compaesano rimasto nel paese, a continuare un tipo di vita che in realtà solo in minima parte è ancora quella di un tempo. Pietro Massa, però, ha qualcosa di particolare. E' poeta, e con timido pudore sottopone le sue liriche al giudizio del vecchio compagno di giochi che ora scrive sui giornali ed è diventato un uomo importante. Le riflessioni che il narratore formula sulla fatica che deve essere costato a Pietro il far rimare pena con cadena, cioè il rispetto di norme arcaiche, vincolo e al tempo stesso occasione di espressione, vogliono con tutta evidenza riferirsi in uguale misura alla fatica costata allo stesso autore, poche righe sotto, il far rimare moine con bambine, e in generale il costringere il discorso entro schemi di ritmo, quando non addirittura di rima.
Ma la visita a Pietro, se permette al lettore di cogliere, per così dire in limine, qual è la modalità espressiva che si deve attendere da questo libro, è altrettanto importante, e introduttiva, perché è in questa occasione che emerge un ricordo chiave, quello che dà il titolo al libro, il gioco del mondo. La figlioletta di Pietro ci gioca esattamente come prima di lei ci avevano a suo tempo giocato il narratore e i suoi coetanei, con una sola differenza, ma capitale. Gioca all'interno del cortile a un gioco che nella mente del narratore è indissolubilmente legato allo spazio pubblico, alla strada, all'asfalto o al cemento o alla terra battuta su cui si tracciavano le figure geometriche di una "campana" (altro nome dello stesso gioco, accanto a "marella" e "strascico").
E' un gioco, dice il narratore, che si prestava a esercizi di forza e di abilità, a improvvisazioni e rappresentazioni, un gioco, appunto, in cui poteva entrare il mondo, anche nelle sue realtà più impervie e meno infantili, quali la morte.
Non è solo il titolo che questo gioco dà al libro, ma anche la sua struttura. Nove caselle sono sormontate da una sorta di cupola, o decima e ultima casella, che compie la campana, così come i nove capitoli evocativi del libro sono completati da una conclusione in qualche modo esplicativa, che corona e chiarisce il senso del gioco sin lì condotto. Ogni casella è dotata di una sua fisionomia (una è dedicata alle donne, una alla politica, una agli artigiani etc.), ma contiene al tempo stesso una eccezionale varietà di destini e di storie, che variamente si intrecciano e si rimandano reciprocamente, a contatto e a distanza. Piano piano, dall'apparente caoticità e casualità dei ricordi, si potrebbe dire dei bozzetti, emerge un piccolo cosmo: è un disordine che fa sistema.
Il libro di Angioni non è e non vuol essere un reportage documentaristico, un insieme di cronache per così dire fotografiche di un mondo agropastorale scomparso o perlomeno in via di estinzione. La precisione e la fedeltà del dato sociologico, pur presente e importante (e non potrebbe essere diversamente, dato l'autore, docente di antropologia all'Università di Cagliari e uno dei più attenti studiosi della realtà sarda nei suoi molteplici aspetti), non costituisce qui, evidentemente, il punto centrale d'interesse.
Sono intanto indicative le scelte stilistiche e linguistiche. Angioni sceglie di scrivere in un italiano in cui le parole ed espressioni sarde sono sempre immediatamente accompagnate dalla traduzione. Ma la lingua nazionale è arricchita di costrutti appartenenti all'italiano regionale sardo o addirittura di calchi diretti dal sardo, sempre operati in modo da non compromettere la comprensione anche da parte dei "continentali". Questi costrutti e questi calchi sono impiegati da Angioni, insieme alla elaborazione ritmica cui si è già fatto cenno, per costruire uno stile personalissimo, in cui l'identità "isolana" si manifesta con tranquilla sicurezza in simbiosi con quella "italiana", senza dare spazio a rivendicazioni etno-culturali sulla cui pochezza e inconsistenza lo scrittore si è più volte soffermato (si veda per esempio il recente Pane e formaggio, Zonza edit. 2000, pp. 119-130). E non è certo, quella di Angioni, una lingua da referto documentario. Molto più, è una lingua suggestiva e evocatrice, che accoglie espressioni colloquiali e perfino volgari accanto a eleganti allusioni a scrittori come Dante, T.S. Eliot, Marguerite Yourcenar etc., a cogliere le quali il lettore è da subito stimolato dai versi di Giorgio Caproni posti in epigrafe.
Nella brevità, nella stringatezza con cui vengono stilizzati, fatti e persone sono di fatto circondati di un'aureola di leggenda, vivida e favolosa anche se applicata a realtà per lo più quotidiane e spesso quasi banali. Ciò che importa è attivare un processo di recupero che permetta di fissare quei fatti e quelle persone in uno spazio mentale, in un orizzonte rappresentativo che renda loro giustizia. Per tutto il libro corre come il senso di una colpa, la consapevolezza larvata di un tradimento, esplicitato nella figura dell'intellettuale che periodicamente si riavvicina al mondo che è stato suo, e che non lo è più, ma di cui tutti si sono macchiati, anche il poeta in sardo Pietro Massa, anche i vecchietti che seduti al sole passano il tempo a rivangare vecchie memorie. E' la realtà contemporanea che nel suo stesso essere si è macchiata della colpa di un abbandono senza ritorno, ma non senza rimorso. La velocità con cui la mutazione antropologica che tanto aveva angosciato Pier Paolo Pasolini ha avuto luogo anche nei recessi più isolati di un'isola già di per sé, si scusi il gioco di parole, isolata, rischia di portare con sé un oblio completo e irrimediabile di un passato recente che risulta incomprensibile. Il pericolo è una condizione di sradicamento, di perdita di identità che solo una grande e pericolosa ingenuità può pensare di superare con un culto del folklore che non aiuta davvero a fare i conti con ciò da cui si proviene, con ciò da cui non si può prescindere per essere. Il narratore si trova a parlare con un suo vecchio compagno che gli dà del Lei. Alle sue rimostranze Mario reagisce con tutto il possibile imbarazzo, esibendosi in giri di parole e di frasi con cui riesce accuratamente ad evitare sia il Lei che il Tu. Entrambi sembrano sentirsi in colpa, perché fra di loro non esiste più quel contatto immediato, quel mutuo riconoscersi, che nel loro antico mondo era garantito dall'esistenza di una comunità nel senso forte del termine. Ciò che in tutto il suo percorso, a salti e a balzi, come richiesto dalle regole del gioco, il narratore cerca di ricostruire, è forse proprio l'intreccio fra individuo e comunità, fra la memoria privata e quella collettiva.
È qui che si gioca la scommessa di quello che può essere considerato il protagonista di questa storia senza intreccio. Il personaggio che solo a tratti compare dicendo "io", il cui punto di vista risulta comunque dominante e funge da autentico filo conduttore del libro (sostanzialmente un io lirico), è uno che "ritorna", che non solo è stato lontano, ma che continua a esserlo, anche perché, e lo annunciano i versi di Caproni in epigrafe, non si può davvero tornare in un luogo che non esiste, perché restare e tornare sono la stessa cosa, sono eventi mentali, o meglio esistenziali, che acquistano senso solo all'interno di una costruzione che è sempre in divenire, mai data una volta per sempre.
Come accennavamo all'inizio, non si tratta di presentare un'immagine rosea e bucolica di questo passato che fatica a passare, non si tratta di dipingerlo come un'arcadia felice che magari andrebbe presa come modello. In primo luogo si trattava di un mondo governato da leggi durissime di sopravvivenza e spesso di sopraffazione, dominato dalla più cruda necessità; in secondo luogo assunto basilare di tutta l'operazione di Angioni è che di un passato irrevocabile appunto si tratta, al quale non avrebbe senso praticare una sorta di respirazione artificiale. È un passato che, semplicemente, come tutti i morti, come Flebas il Fenicio, come l'animula vagula di Srabadoi Canargiu, chiede di essere decorosamente sepolto e ricordato. E allora ecco che il gioco del mondo, che è anche e in primo luogo il gioco della poesia, dell'incanto, della rievocazione magica, diventa un vero e proprio esorcismo, rivolto tanto al passato quanto al presente e al futuro: è dai tanti morti cui direttamente o indirettamente, esplicitamente o implicitamente, il poeta dà sepoltura di parole e di affetti che egli si aspetta di vedersi tendere, giunto il momento, una mano amica, a rendere meno aspro il passaggio, ma soprattutto a dotare di senso l'attesa.
L'ultima casella di questo gioco del mondo, la cui posta è la salvezza di un mondo, è quasi per intero occupata da due figure che, aldilà della loro eventuale realtà biografica, assumono una fortissima valenza simbolica. Sono marito e moglie, una coppia mitologica, l'inizio e la fine, il becchino Morrideppeus Pomoredeus e la levatrice Maria Levadora. In essi si incarna la tradizione, trova rappresentazione la realtà del trapasso da una generazione all'altra e, perché no, da un mondo a un altro, sul filo di una volontà di comprensione e di accettazione che sola può eliminare il ritorno di fantasmi che partoriscono mostri.