
In alto una collina, in basso le onde del mare. Un rosario di parole, storie che si sgranano una dopo l’altra e narrano le opere e i giorni di un pastore di Fraus. Gioie, dolori, passato e presente: di un individuo e di un popolo. Insieme, “il gusto” e i suoi mutamenti, e quelli dell’economia. Sono il filo di diversi colori lungo il quale corre la trama in versi che Giulio Angioni tesse con la sua ultima opera “Oremari”, edita dal Maestrale. Due racconti in due lingue - l’italiano e il sardo - due sistemi di pensiero, il soffio composito dell’artista e dell’antropologo, lo sguardo duplice nella simbiosi poetica, lungo i binari di una scrittura glabra di orpelli e ricca di senso, che si bagna nelle acque del mare e si nutre del pane della terra, e della tradizione. E li rappresenta con gli occhi, le paure e i desideri di chi, del mare, sente il richiamo ma sta con i piedi sulla terra con l’equilibrio instabile del dubbio e della precaria vertigine pascoliana, a dire la doppia radice della sua isola. “Perché affidarsi al mare o peggio al cielo/ col peso della carne ancora viva?”
La saggezza di chi, sedotto dall’eterna sirena marina, come Ulisse non cede, stretto alle corde della sua memoria. Chi ha ceduto, come Fanni Giovanni, il ruspista, che “adesso lascia tutto e scappa via,/ nella fuga d’amore prende il mare,/ senza più religione dell’affare,/ perso il fiuto di cane e d’avvoltoio”, consuma i suoi giorni in altri luoghi, nell’abiura irrisoria della poesia paterna. E infatti “Suo padre (…) si è rifatto poeta come in gioventù/ (…) ne ha detto delle belle,/mettendolo in canzone,/ quel ribelle,/ ripreso vacanziere a braghe corte/su quella grande nave da crociera,/regina o baldracca sia del mare”.
All’inizio il fare prudente: “Il mare: io sto qui, lui sta lì”, la difesa nella reciproca lontananza, nonostante la visione ravvicinata. Due realtà, in apparenza indifferenti l’una all’altra, e in mezzo la soglia. La condivisione liminare, la linea di confine e il connubio fra terra cielo e mare. E nella cronaca della sua vita che, man mano, il capraro va componendo in prima persona, il racconto di sé e di un’isola, del sud che diventa l’ogni luogo, l’ogni soglia che la geografia ha lasciato apparentemente uguale, che la storia ha profondamente mutato. Agli antichi sono subentrati altri predoni, soggiogati dalla bellezza mercificata - “le case di gatò” - e dai cibi dal sapore ancora arcaico, alla ricerca di un mondo primigenio che ha invece imparato l’arte della metamorfosi, dentro le nuove logiche del profitto.
A tratti Angioni costruisce un nuovo Titiro e il suo fugace compagno Melibeo che dai luoghi no, ma da antiche consuetudini è ormai distante e ne sente il rimpianto “Meglio la gioventù di povero pastore.” / Mai contenti si sa. “Tu sì,” mi dice, “tu sì che te la passi bene”, eppure niente rimanda al clima bucolico, se non forse un certo divertito distacco teocriteo con cui si ritraggono alcune scene. Lontana da quella della memoria, la vita è quella reale, seppure unita al rimpianto per ciò che si avverte perduto di fronte “al mondo rovesciato”. Dietro risuona l’eco georgica del libro terzo, dell’allevamento di pecore e capre: “io so di capre in terra/dove la capra a me fa simpatia” perché, chiarisce, “Sono uomo di terra. Troppo”. E il lavoro, il contatto con la natura, il recupero di un’umanità più autentica, il tono semplice e colloquiale. Insieme, si fanno poesia le risonanze sentimentali, gli echi degli eventi contemporanei, lo tsunami, le frane, i mutamenti ambientali, il buco dell’ozono, Feisbuk, l’intrico della sorte dell’uomo e dell’economia, la grande metonimia che dilaga sotterranea sul poemetto.
“Oremari” è spiegazione dell’autore stesso: “Oremari”, si dice qui da noi/ per dire “orlo di mare”. Oggi ha due sensi nuovi da spiegare,/ come il maestro a scuola,/forse, se mi permette,/vale la pena. Dunque:/”Oremari” per dire “ora di mare”, mai creduta, nemmeno immaginata,/ ai tempi anche soltanto di mio padre,/l’ora nuova turistica del mare/(…) dunque “oremari” a dire “oro di mare””.
Il sistema di valori, a cui il racconto in versi si conforma, è quello della famiglia; e sono il padre e le sue battaglie, la madre, il pane e il suo complesso corredo simbolico. Da quella prospettiva il mare appare così l’antimondo e “Comunque, l’ho passato anch’io/ il mare per dovere, quattro volte/ (.…) la prima volta ancora mi sorprende,/ la notte dei maiali spaventati./ Militare di leva/ (…) e il mare fuori senno che ti balla/ i balli tutti della terra ferma/ a suoni di tempesta./” Ma è anche il mondo parallelo con il suo carico epico e narrativo, di segni e immagini. Ed ecco il nuovo albatros, un più modesto gabbiano, lontano da sospette interpretazioni baudelairiane: “Bello in volo è il gabbiano/come un angelo in cielo,/ o sul mare in picchiata sulla preda./ Ma qui a terra il gabbiano vale poco,/ fa i passi goffi e cerca i letamai./ Il cielo è il luogo suo,/ e tu disteso all’ombra/ (novello Titiro!) ... /la faccia al mare e il sole su che picchia/” “Oremari” è così soglia e limite da non valicare, se si può, per ciò stesso affascinante, misterioso. Ma pur stando sul ciglio, il figlio di Fraus interpreta gli echi che il mare riporta, i mutamenti, le novità. Decifra le onde, il loro andare e tornare, e col loro suono intesse parole e nuove storie e ha l’occhio lungo, dall’alto della sua collina.
E se la vicinanza non è amica, il rispetto è tale che al cieco ascolto di un piccolo uomo si affida il poeta, e al racconto del nipote del prete che, in modi straniati, “mimando con la voce e tutto il corpo,/ ci fa tutte le onde, grandi e brevi,/ lunghe e piccole, basse, alte,/ spruzzi, scrosci, rimbombi/” e ne riproduce la vitalità, ne assume la corporeità e infine formula, sul mare, il giudizio di valore con le parole “bello e buono”, in una sintesi omericamente perfetta.
Angela Guiso

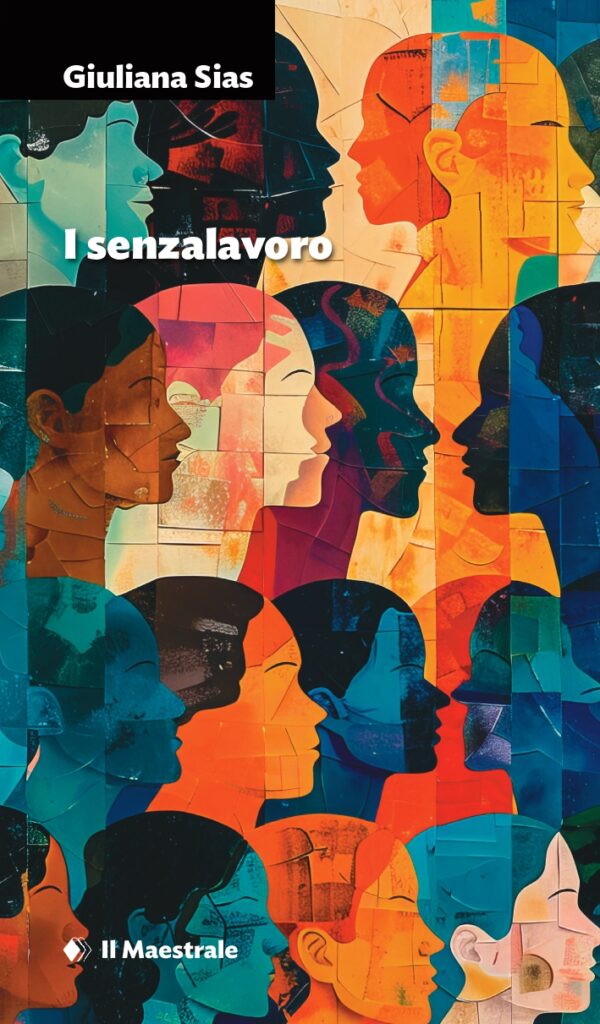

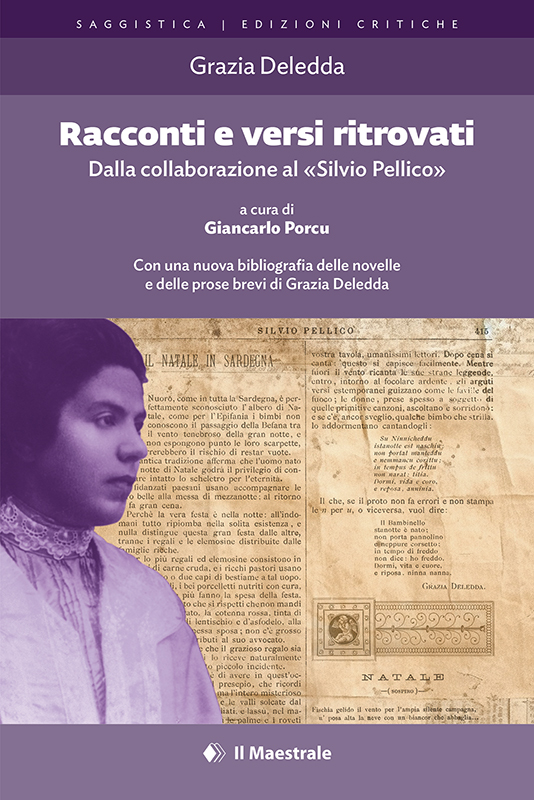

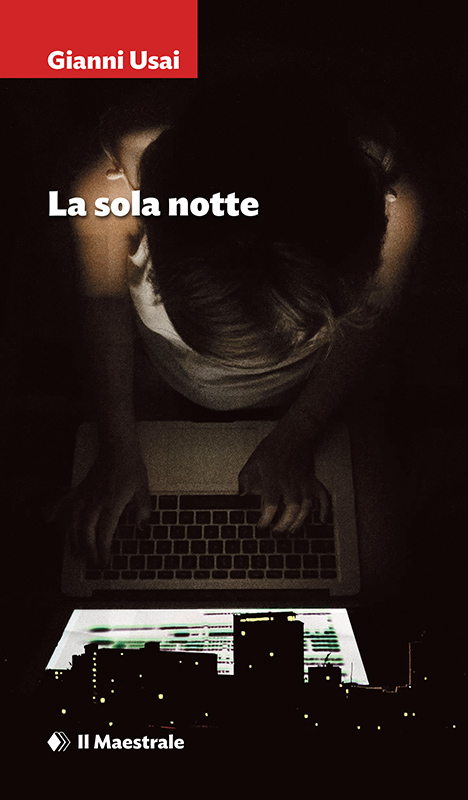









DISTRIBUZIONE : (Gruppo- Mondadori)
A.L.I. AGENZIA LIBRARIA INTERNATIONAL S.R.L.
VIA MILANO 73/75 –
20007 Cornaredo-MI ...
Tel. 0299762430-1-2
Fax 0236548188
E-Mail infoali@alilibri.it
ORARI Dal Lunedì al Venerdì 08:30-12:30 /13:30-17:30
RETE PROMOZIONALE- LIBROMANIA

