
Storie di famiglie, o quanto meno veicolate, strutturate, monopolizzate da nuclei familiari, clan, raggruppamenti tribali e comunque imprescindibili da legami parentali: si tratta, da alcuni decenni ormai, di un elemento ricorrente della narrativa degli autori isolani.
Altro tratto distintivo di quella che, beninteso, è una stagione ricchissima per la letteratura sarda (cioè la letteratura degli autori sardi), è l’autorità pressoché assoluta del narratore sull’oggetto del narrare, sancita dalla presenza marginale di dialoghi e dal peso invece preponderante del discorso indiretto. In sostanza, leggere questi romanzi significa affidarsi - senza se e senza ma - al “conto”: “conto” perché la fabula non nasconde e, semmai, ostenta la propria radice nell’oralità, nell’affabulazione.
Anche nel caso dell’ultimo romanzo di Alberto Capitta, Alberi erranti e naufraghi (Il Maestrale, 16 euro) la voce domina la scena e plasma il mondo intorno a sé. Anche Capitta, come Marcello Fois, Michela Murgia, Flavio Soriga - per citare solo i più famosi- avoca a sé non solo lo sguardo, ma anche il bilancio su ambienti e personaggi. Prendere o lasciare: il lettore può solo condividere o rifiutare questa tirannia dell’autore sulla storia, perché solo a questa condizione il meccanismo romanzesco funziona. Evidentemente non siamo di fronte a una narrativa di tipo realista, ma piuttosto a una prosa in cui emergono analogie con il monologismo, il riaffacciarsi del mito, il cosiddetto realismo magico, tutte tecniche diffuse su scala mondiale nella vastissima rassegna degli autori postcoloniali.
Anche Capitta rientra, pur secondo modalità molto personali, in questa categoria e il suo ultimo romanzo, nonostante le dimensioni non particolarmente cospicue – 200 pagine – ha il taglio di un’opera mondo. Secondo la definizione di Franco Moretti, un’opera mondo è un esempio di epica moderna, diversa dall’epica classica o da quella di un Ariosto o Boiardo non solo perché è in prosa e non in versi, ma piuttosto perché registra discontinuità e incongruenze piuttosto che celebrare l’unità coerente del mondo che fu, in epoca premoderna. Eppure, nonostante le ovvie differenze, anche Capitta, come Ariosto, ha intenzione di raccontare il mondo –non quello cavalleresco- nella sua interezza. E lo fa, come Garcia Marquez con Macondo, partendo da un centro periferico, in una Sardegna dai contorni vaghi ma dalle distanze continentali, i cui abitanti sono però rappresentativi di una condizione umana. Questo mondo dunque si dipana attraverso le vicende dei componenti di tre famiglie, gli Arca, i Nonne e i Branca, ognuna caratterizzata da stili di vita e filosofie di vita diverse e, in certi casi, antitetiche.
Piero Arca appare sulla scena come il più enigmatico ed affascinante di questi personaggi : sul suo capo il figlio Giuliano vede irradiarsi una luce azzurrina, e anche la moglie, Chiara Mereu, intravede sul suo capo “una luce da santo che non la faceva stare tranquilla”. Arca è colui che si dice un reietto, o, peggio, “un rifiuto” per i benpensanti, a causa di questa sua confidenza simpatetica con la natura, per la sua stessa “faccia impastata di natura, di ritorno dal paese di Arcimboldo”. Sebastiano Nonne, ricco e arrogante possidente, e il figlio Michelangelo, militare di carriera, rappresentano il lato torbido della storia, protagonisti, fucile alla mano, di una “crociata contro il movimento” dove il movimento è rappresentato dagli animali, che i due sterminano in una patologica ossessione venatoria. Le bestie, care a Piero Arca, che in esse si identifica fino a “liquefarsi”, sono il discrimine della storia. Maddalena Branca si innamorerà, contro il parere del padre, di Michelangelo Nonne, ma la sua vicenda, una volta che incrocerà quella di Giuliano Arca- il quale, a sua volta, cerca il padre scomparso- sfocia nella presa di coscienza di una frattura insanabile: o con gli animali – come gli Arca- o contro di essi, come i Nonne. Per Maddalena sarà un trauma che condizionerà le sue scelte affettive ed esistenziali.
Si ripresentano in lei alcuni tratti di Carmen, la protagonista del precedente romanzo di Capitta, Il giardino non esiste: figure femminili che scoprono le potenzialità nascoste di una vita ai margini, nomade, dove, in determinati luoghi e grazie a particolari disposizioni d’animo, ci si può emancipare dall’inquietudine insita nello stile di vita dominante. Ai margini si può ritrovare, insomma, quell’armonia grazie alla quale, rispetto agli animali, ci si sente “continuati, dove finisce uno inizia l’altro”. Il rilievo che Capitta dà agli animali richiama uno dei saggi più ispirati di John Berger, intitolato appunto “Perché guardare gli animali?”. Berger, romanziere e artista, ci spiega che negli ultimi due secoli gli animali sono gradualmente scomparsi dalla nostra cultura e dalla nostra frequentazioni; ma la rottura decisiva fra noi e loro si era già consumata con Cartesio, nel momento in cui il filosofo separò nettamente il corpo dall’anima. Da quando l’animale è stato svuotato di esperienza e di segreti, è stato collocato in un passato irrevocabile. “Questa riduzione dell’animale, la cui storia è tanto teorica quanto economica, fa parte dello stesso processo che ha ridotto gli uomini a isolate unità di produzione e consumo”. Credo che Capitta potrebbe sottoscrivere questa diagnosi, etologica e politica insieme. Certo una pressante urgenza etica lo spinge a optare per una scrittura spesso “compatta” (zippata, se mi si passa il termine informatico) nella quale la narrazione si affida a riuscite (grazie anche alla sua pratica giornalistica) epifanie nelle quali sintetizza il fatto e il giudizio su di esso. A suggello del creatore sul mondo inquieto, cui lui stesso ha dato vita.
Mauro Pala

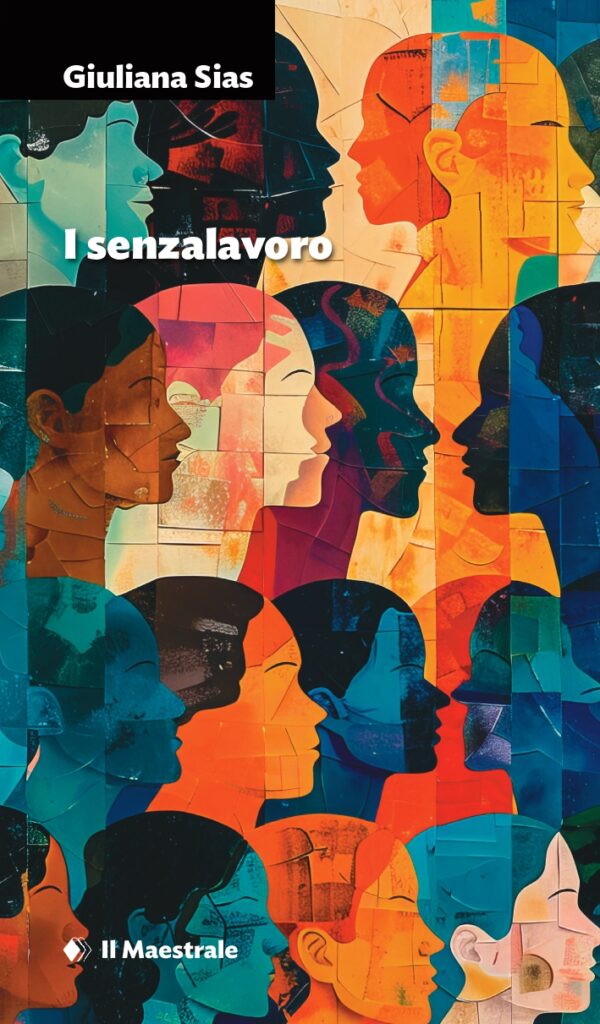

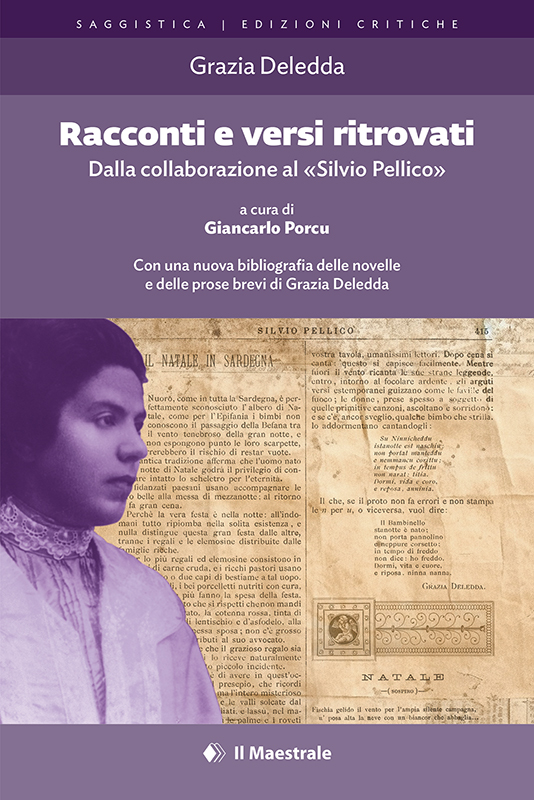

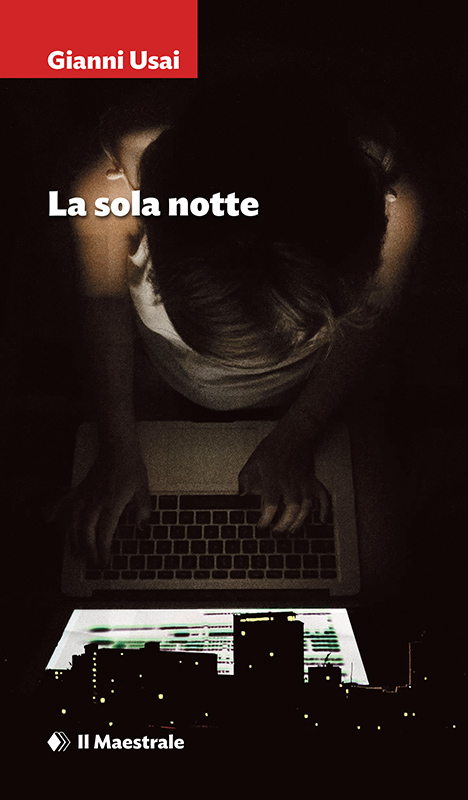









DISTRIBUZIONE : (Gruppo- Mondadori)
A.L.I. AGENZIA LIBRARIA INTERNATIONAL S.R.L.
VIA MILANO 73/75 –
20007 Cornaredo-MI ...
Tel. 0299762430-1-2
Fax 0236548188
E-Mail infoali@alilibri.it
ORARI Dal Lunedì al Venerdì 08:30-12:30 /13:30-17:30
RETE PROMOZIONALE- LIBROMANIA

