
Si respira un’aria di sollievo nel compimento di una sorte quando, nonostante le avversità, ha potuto dare seguito al proprio desiderio. Insieme alla piccola catastrofe quotidiana di gesti minuti, molte gioie e altrettanti dolori, che segnano l’inventario di una vita lunga giunta quasi al suo termine. Lo sa bene Savina Dolores Massa che nel suo ultimo romanzo, «Il carro di Tespi» (Il Maestrale, 313 pagine, euro 16) percorre la parabola umana di Antonio Garau, commediografo oristanese scomparso nel 1988 all’età di 81 anni. Una biografia ispirata «liberamente», si specifica nel sottotitolo, rispondente all’ampiezza della scrittura di Massa, che sceglie di non seguire la forma del romanzo storico, ma eccede fra la fedeltà ad alcune fonti consultate e il memoir, con inserti di finzione e sfasamento di piani linguistici. È lo stesso A.G. che nel suo protagonismo racconta di sé, una prima persona singolare che tuttavia, per chi conosce i libri precedenti della scrittrice, si declina nello smarginamento di una intera comunità. Anche qui, come in «Cenere calda a mezzanotte» (2015), a essere centrale è infatti lo sguardo su Aristànis. Sullo sfondo, l’annodarsi di vite semplici lambisce gli abissi di un uomo giunto ai suoi 80 anni che decide di mettere ordine nella propria storia. Il risultato è una parola letteraria sapiente, scavata con intemperanza, frutto di un corredo che va dalla magistrale visionarietà di Anna Maria Ortese alla irriverenza tagliente di Jolanda Insana. La biblioteca di cui si serve Savina Dolores Massa è infatti intrecciata alla scrittura letteraria e a quella poetica, un esercizio di contaminazione che sa individuare l’incanto per il mondo puntellato sul tormento della realtà. Tribolata è la realtà, lo ammette la voce ironica e dolente di un acronimo. E il cruccio non è solo quello di A.G., nato per scrivere commedie e obbligato dal padre a fare il merciaio fin dalla prima giovinezza. In quel tribolo gravitano anche gli anonimi altri che la Storia tritura, con nomi ugualmente puntati o mai detti per intero. È il caso dei naufraghi di «Undici» (2008), di Maddalenina in «Mia figlia follia» (2010, tradotto di recente in Francia da Laurent Lombard per le Editions de l’Ogre), delle figurette di «Ogni madre» (2012). Tutti, fra le mani della scrittrice, appartengono a un unico intarsio di attesa e sortilegio che li ha sottratti alla miseria per raccontarne il dissesto. È vero però che «Il carro di Tespi» non convoca soltanto la sopravvivenza degli ultimi, come a dire che non è soltanto l’ingiustizia della dimenticanza a dover essere combattuta. Ciò a cui si accede in questo ultimo libro è piuttosto la libertà di adesione a una vita già colmata dalla grazia dell’arte. Dal 1934, anno della prima opera che racconta le vicende di un barbiere, al 1983, data dell’ultima commedia dedicata all’immaginaria Aquafrida, l’intenzione di Antonio Garau è stata sempre quella di cercare un elemento di scarto e raddoppiamento. Lavorare sui testi in campidanese, concentrarsi sull’idea di un teatro che restasse itinerante, colloquiare con «una popolazione avida di felicità» anche alla fine di una guerra, restituisce il senso mobile del carro di Tespi, montato e rimontato nelle piazze. Dettagli che emergono anche nel libro di Massa, ma che sono forse i meno importanti, in fondo – come A.G. rammenta – si può sempre ricorrere alla lettura diretta delle commedie, negli anni pubblicate e interpretate. La costruzione che quindi interessa è il tessuto affettivo etico e morale, capace di riferire il mondo grande e terribile non come una serie di fatti trascurabili, bensì come ciò che capita ai viventi poi visitati dai ricordi. Si sgranano allora la vicenda della anziana Annìca, di Maria José morta a dieci anni per una febbre di giugno, di Assuntina nel controcanto coniugale. E poi Rosalia, sorella dei sospiri estremi, a lei «sono nate ali al contrario perché volare verso la terra non è peggio dell’aspirare al cielo». Suddiviso in tre atti, il tragitto di Massa disegna una ulteriore sceneggiatura che sa dipanarsi nel tempo lungo della letteratura con agio e che, d’altra parte, svela i segreti tumultuosi di una genealogia di voci. Sono di donne e uomini, dallo sprofondo lontanissimo poggiano sul presente tutto da inventare. Eppure anche ciò che non è animato può rendersi parlante. «Non siate piccole cose», scansato questo pericolo di cui avverte A.G., abbiate la cura di saperle ascoltare, le cose, «camminando un po’ perduti in una libertà che si chiama solitudine».

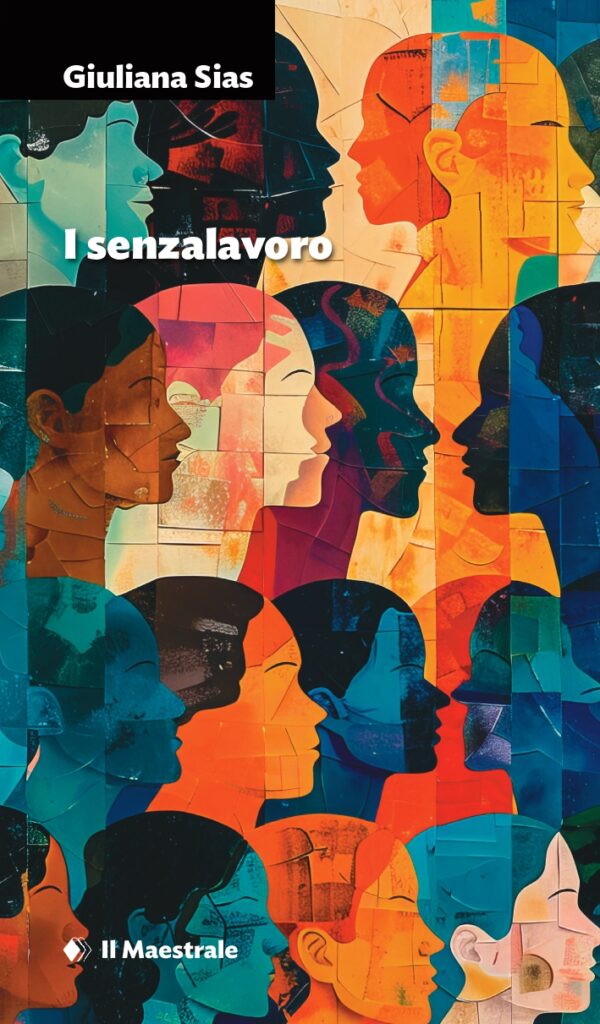

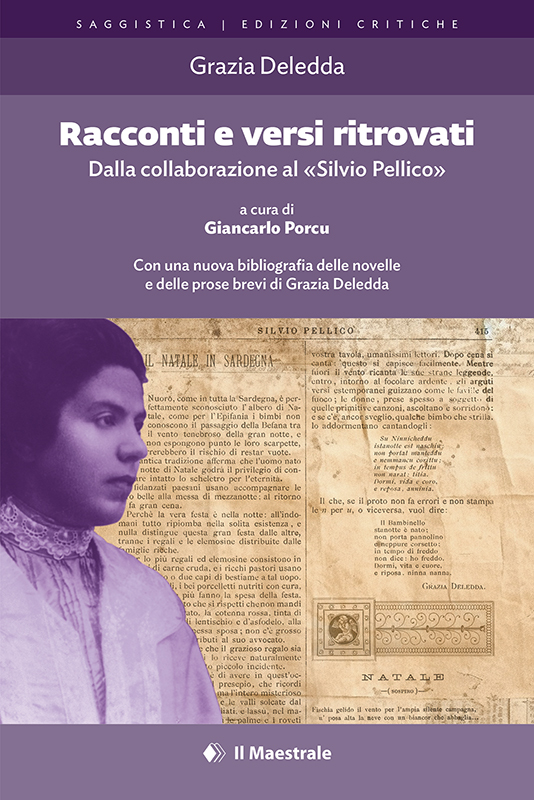

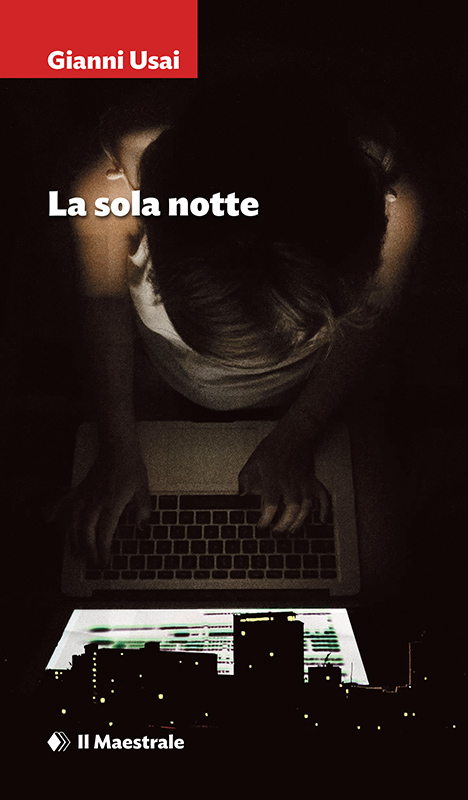









DISTRIBUZIONE : (Gruppo- Mondadori)
A.L.I. AGENZIA LIBRARIA INTERNATIONAL S.R.L.
VIA MILANO 73/75 –
20007 Cornaredo-MI ...
Tel. 0299762430-1-2
Fax 0236548188
E-Mail infoali@alilibri.it
ORARI Dal Lunedì al Venerdì 08:30-12:30 /13:30-17:30
RETE PROMOZIONALE- LIBROMANIA

