
Una notte di orrore e sangue
A raccontare, nel libro, è un vecchio, al quale resta poco da vivere. Dicono, le sue parole, di una notte di luglio del 1258, quando la città di Santa Gia, nella Sardegna di pianure e di paludi all’estremo lembo meridionale del Campidano, fu rasa al suolo dagli armati di Pisa dopo un lunghissimo assedio. Gli abitanti scampati alla morte per fame furono passati a filo di spada, le case demolite e bruciate, sparso il sale sulle rovine fumanti. Fatto storico effettivamente accaduto, episodio della guerra che oppose, nella lotta per il dominio sulla Sardegna, Pisa a Genova. La Santa Gia di Angioni è infatti Santa Igia, la capitale dei signori del Giudicato di Cagliari, alleato dei liguri. L’uomo che racconta si chiama Mannai Murenu e ricorda fatti accaduti quand’era un ragazzino. Sono passati settant’anni da quei giorni e davanti agli occhi stanchi di Mannai tutto si ripete. Ricorda, il vecchio, di quando si trovò, quasi privo di sensi, sotto le macerie della casa del vinaio di cui era garzone; di come scampò al colpo di grazia delle picche pisane fingendosi morto; di come riuscì a sfuggire alla caccia e a prendere la strada dell’unico luogo che sembrava garantire salvezza: il grande stagno accanto al quale la città distrutta era nata.
L’ebreo Baruch
Su quella strada Mannai ragazzino trova altri scampati alla strage pisana: Paulinu, servo in un convento, dove fa i lavori più umili ma anche copia gli antichi manoscritti; il vecchio ebreo Baruch, che ha fama di mago; Tidoreddu, pescatore che delle acque salmastre e paludose conosce tutti i segreti. E due donne: Vera, enigmatica e misteriosa, forse giovane dama di una nobile famiglia genovese, e Akì, serva nella casa di una facoltosa famiglia sarda di Santa Gia, adolescente arrivata dalla Persia nella grande isola al centro del Mediterraneo, non si sa attraverso quali storie di traffici e quali percorsi di carovane e di navi. Sono della compagnia anche tre mercenari tedeschi al soldo dei genovesi e il cane Dolceacqua, guardiano prezioso ad avvertire delle sortite delle soldataglie pisane. Trovano tutti rifugio nell’isola al centro dello stagno sino a poco prima abitata dai lebbrosi. Il lazzaretto è stato svuotato dagli assedianti toscani, che i contagiati li hanno tutti lanciati con le catapulte oltre le mura di Santa Gia, per sommare alla fame la malattia. Al piccolo nucleo iniziale si aggiungono altri, sino a un centinaio. Si fingono lebbrosi, e così riescono a tenere lontani i nuovi padroni vittoriosi sui vecchi signori.
Il racconto di Akì
Mannai ricorda. E con lui ricorda Akì, diventata sua moglie, ora compagna degli anni estremi della vita. Raccontano perché, dice Akì, «ci sono cose che riesci a vivere solo se le dimentichi, e altre che riesci a vivere solo se le ricordi. Lo stesso è per riuscire a morire come si deve». Ricordano, i due anziani sposi, il dolore che nasce dalla violenza ma anche la speranza ostinata: «Quella notte – dice a Mannai Akì ormai vecchia – ho subito riconosciuto in voi non dei pericoli, non dei nemici, non dei maschi qualunque predatori. Ma ho visto in voi ciò che eravamo noi: figli della sconfitta, fuggiaschi come noi, capaci di speranza come noi. Vera e io abbiamo preso un ago e un ditale e un rocchetto di refe francese. Per rammendare i vostri vestiti logori, strappati, bruciacchiati. Per rammendare la vita di noi tutti. E un pezzo di pasta che stava fermentando nell’orcio di terracotta. Per il pane della prossima volta». La solidarietà tra oppressi e la speranza di un mondo giusto, non senza dolore, ma almeno senza sopraffazione: il pane della prossima volta. Questo è il nodo tematico più immediato nel racconto di Angioni. Legato al rapporto tra uomo e natura. Alla poderosa macchina di morte che si mette in moto, fredda ed efficiente, nel giorno in cui Santa Gia viene distrutta, alla violenza cieca che si scatena contro i più deboli, si contrappone l’ordine dello Stagno. Lo Stagnoche, colmo di vita animale e vegetale, nutre gli uomini d’acqua e di cibo sin dalla notte dei tempi. «C’è tutto nello Stagno e tutto è più antico dell’uomo, più della sua pochezza, senza la sua nequizia», dice Mannai . E Baruch aggiunge: «Alla natura si comanda ubbidendole». Alla vita si comanda ubbidendole: solo così si può preparare il pane della prossima volta, l’orizzonte nuovo oltre la resa e la disperazione.
Come Sherazade
E però non è questo il livello più profondo di “Sulla faccia della terra”. Il filo più riposto e più prezioso è quello che intreccia memoria e racconto, ricordo e parola. «Il mondo – dice la vecchia sposa di Mannai nel capitolo centrale del libro, non a caso intitolato “Il grande racconto di Akì – prende senso se lo raccontiamo, magari come Sherazade, la mia compatriota che si salva la vita raccontando». «Noi siamo per noi – chiosa il mago Baruch – ciò che riusciamo a raccontare di noi stessi. E per gli altri siamo ciò che loro raccontano di noi». E tutti raccontano la loro storia, nel libro di Angioni, definendo i loro reciproci rapporti esattamente secondo lo schema indicato dall’ebreo. La legge che tiene insieme la micro società dei finti lebbrosi scampati alle spade dei pisani è la legge del narrare.
Nel mondo in guerra
I sopravvissuti sanno che «il vivere non sempre indica direzioni». Paulinu, il servo copista che ha imparato a leggere e a scrivere a rischio della vita, insegna agli altri che «a volte è meglio lasciare le cose per conto loro, non piegarle a sensi e direzioni». «Lui – dice Mannai di Paulinu – è senza inizio e i fini sono mobili e sfuggenti». E però un verso esiste. Paulinu viene da Fraus, il villaggio contadino di tanti libri di Angioni, e «sente la suggestione di storie, di leggende agresti che ancora gli allargano la mente e gli arricchiscono il parlare. E lo fanno capace di dare senso all’ostinazione di esistere in questa indecisione, tra cielo e terra, mare e laguna, nel mondo in guerra».
Dare senso all’ostinazione di esistere attraverso le infinite storie già raccontate o ancora da raccontare. Questo l’unico fine, nel mondo in guerra. Come l’eterna Sherazade, prigioniera non arresa di un tiranno onnipotente.
Costantino Cossu


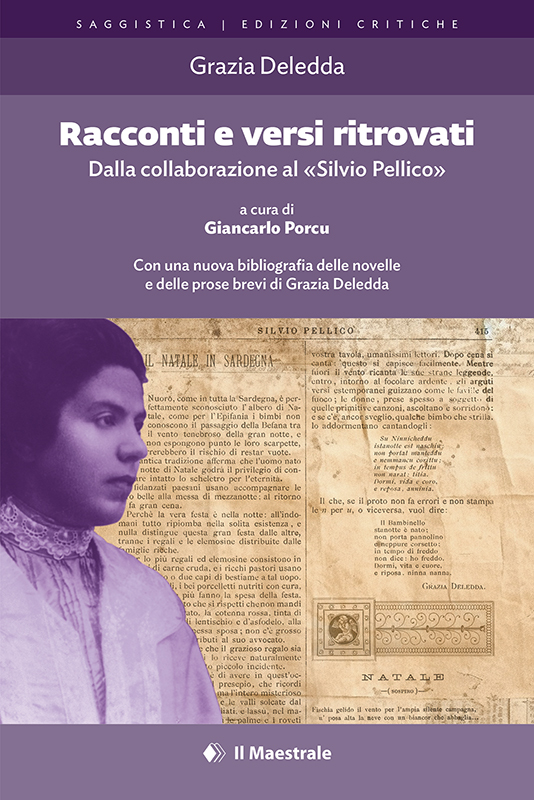
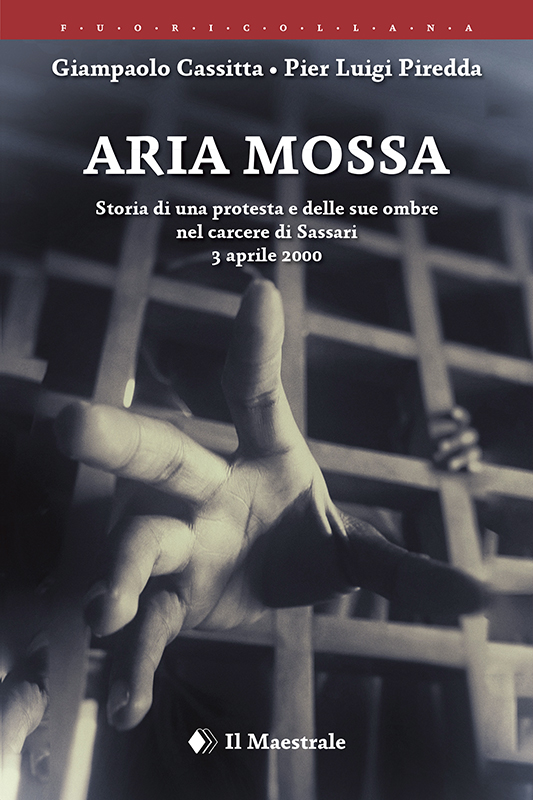

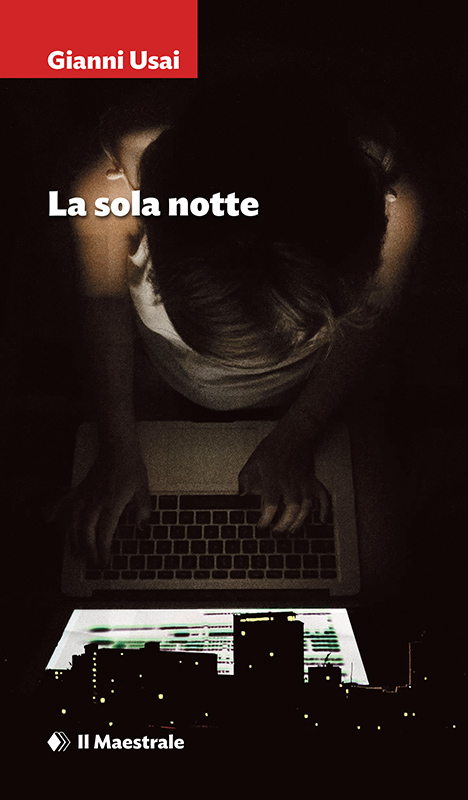









DISTRIBUZIONE : (Gruppo- Mondadori)
A.L.I. AGENZIA LIBRARIA INTERNATIONAL S.R.L.
VIA MILANO 73/75 –
20007 Cornaredo-MI ...
Tel. 0299762430-1-2
Fax 0236548188
E-Mail infoali@alilibri.it
ORARI Dal Lunedì al Venerdì 08:30-12:30 /13:30-17:30
RETE PROMOZIONALE- LIBROMANIA

