
Dopo il successo del primo romanzo, “Il bambino che fumava le prugne”, Luca Ciarabelli si ripresenta al pubblico, esattamente un anno dopo, e ancora per le edizioni “Il Maestrale” con un nuovo romanzo: “Il paese dei Pescidoro”. Il 38enne umbro che, come si legge nella pataletta di copertina “diplomatosi geometra, ha abbandonato la carriera prima ancora di iniziarla, per dedicarsi a questioni di rango inferiori come studiare filosofia e viaggiare”, sembra cogliere l’abbrivio del lavoro precedente, che avevamo avuto occasione di presentare in questa pagina. Anche se scopriamo poi che la stesura di questo volume è precedente, anche se la pubblicazione è successiva. In occasione della lettura de “Il bambino che fumava le prugne” avevamo definito come elemento convincente lo stile, “rappresentando il punto forte del romanzo: una scrittura che, tenuta sul filo dell’ironia, senza mai scadere in quel grottesco pretenzioso o pecoreccio di molta narrativa recente, inventa un linguaggio sui generis”. Ebbene, sicuramente Ciarabelli recupera, o comunque certamente rielabora, uno stile che in questo caso, forse per rispondere in modo più appropriato al “soggetto” narrativo, viene qui come rafforzato, ispessito, magari anche un po’ caricato. Questa volta, infatti, l’autore lascia a casa Santo Ateo Miserino Bonarroti, il tenente dei carabinieri protagonista, che candideremmo volentieri per un ripescaggio: il personaggio ci starebbe proprio bene in un sequel, e si affida a un protagonista di tutt’altro tenore: Cornelio Persico, nato in Argentina da Gustavo Ramiro, emigrato italiano “ripiovuto in patria col bambino e il dolore sudamericano di una donna da dimenticare”. L’ambiente, ancora una volta circoscritto, è quello di Villatiferno, nel cuore degli Appennini centrali, noto come «il paese dei Pescidoro», dal nome della famiglia nobile e terribile che ne ha scritto la storia. Ma la vicenda qui si snoda, inscritta nel guscio di una grande metafora, che vuole raccontare la storia di una guerra di liberazione da teatro dei Féeries, in cui la schematicità dei personaggi e delle situazione, pur diventando paradossale, si legge con chiarezza. Sedotto dalla visione di “Via col vento nel piccolo ” cinema del paese, Cornelio punta a farne una trasposizione drammatica, aiutandosi, in questo, con l’apporto di alcuni personaggi ritagliati nella pietra che, secondo il gusto dell’autore, hanno nomi compositi improbabili, come Eme Dissa-Beghele, Eraldo diMorra, Roberto-cheora- è (così chiamato perché soffre di una sindrome ansiosa legata al tempo). Sembra una cosa innocua, però i potenti di Villatiferno iniziano a vedervi un pericolo, quello della forza delle idee, per quanto pacifiche, e della sedizione dell’arte. Resta fermo nel suo intendimento, e nel suo modo anarchico di vedere le cose, anche quando verrà internato nel palazzo storico dei Pescidoro, rifatto a manicomio e addolcito col nome di «Albergo». Fino a un finale che riserva delle sorprese. A differenza del romanzo precedente (purtroppo i precedenti non possono sottrarsi al confronto), molto più “quadrato” nella sua struttura, nonostante la sua disincantata goliardia, questo secondo sembra più affidarsi a un automatismo di scrittura che rischia, in più di un punto, di smarrire il seguito, anche se è chiarissima l’evoluzione complessiva del soggetto. Che suona comunque come una feroce critica all’autorità costituita e ai luoghi comuni, e che anche questa volta si proietta, come ne “Il bambino che fumava le prugne”, in un finale metafisico, persino un po’ dotto.

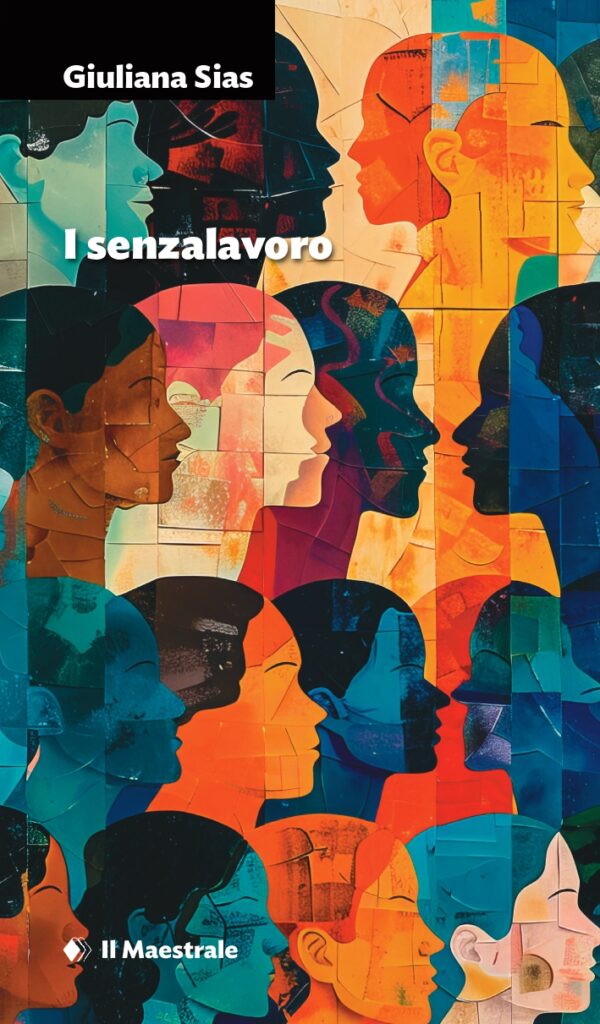

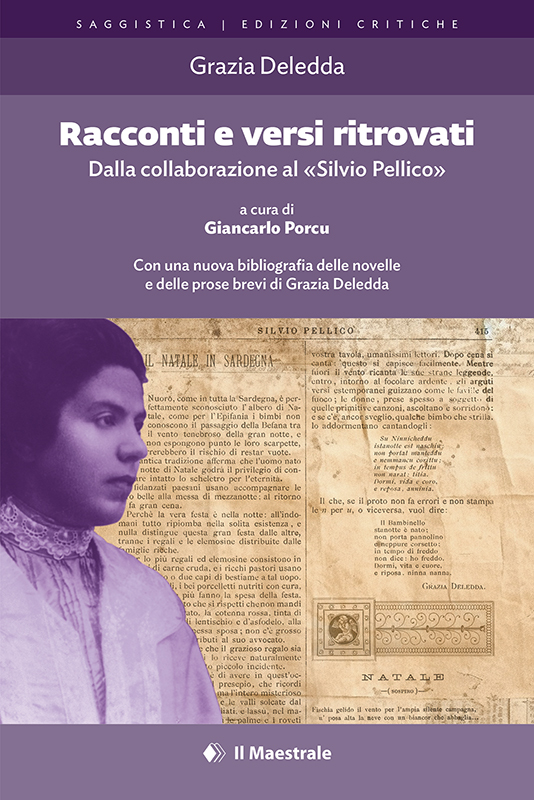

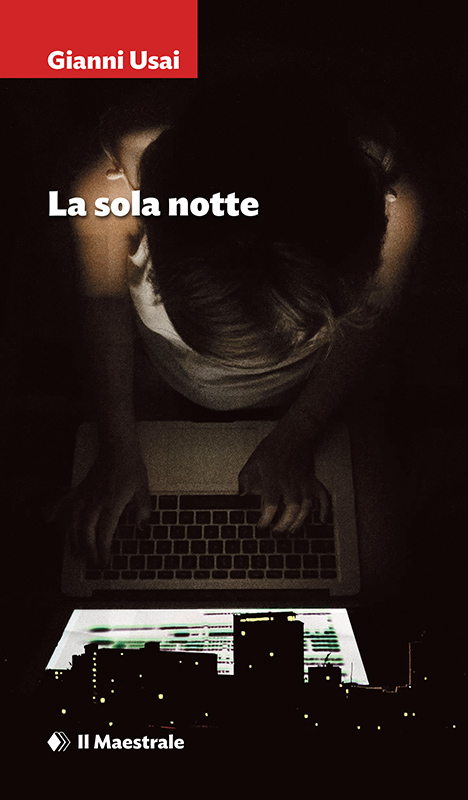









DISTRIBUZIONE : (Gruppo- Mondadori)
A.L.I. AGENZIA LIBRARIA INTERNATIONAL S.R.L.
VIA MILANO 73/75 –
20007 Cornaredo-MI ...
Tel. 0299762430-1-2
Fax 0236548188
E-Mail infoali@alilibri.it
ORARI Dal Lunedì al Venerdì 08:30-12:30 /13:30-17:30
RETE PROMOZIONALE- LIBROMANIA

