
Da circa dieci anni la Sardegna sta assistendo ad un moltiplicarsi delle sue narrazioni. La Sardegna non è più l'incantata isola di Elio Vittorini che, nel 1932, terminando il reportage lirico, Sardegna come un'infanzia, scriveva «Ecco: Sardegna è finita... e io capisco questo: che Sardegna per me è finita, non l'avrò più mai, che è passata per sempre dalla mia esistenza... Ah il nostro torpedone, le nostre corse notturne, e quelle soste in mare, quegli approdi, e le isole che apparivano all'aurora - anche se non si dormiva quattro ore a notte, è stata una mia indimenticabile vita. Come un'infanzia». La Sardegna letteraria di oggi (spesso noir) non è più un'infanzia incantata.
La nostra seconda isola, tra le più complesse linguisticamente, sta vivendo un fecondo corto circuito tra suggestioni e valori antichi e istanze moderniste, finanche all'avanguardia (utile, a tal proposito, la lettura del saggio La new economy nel Mezzogiorno. Istituzioni e imprese fra progettualità e contingencies in Sardegna di Luca Ferrucci e Daniele Porcheddu). La letteratura, ancora una volta, sorge più forte all'interno delle contraddizioni della complessità (o della crisi di vecchi valori), a riconferma dell'assunto (dionisottiano) che lo scrittore trae un linguaggio e una visione del mondo da una terra specifica, da un sound sintattico particolare.
I due pilastri del linguaggio letterario sardo moderno sono Grazia Deledda e Antonio Gramsci; la prima, assurdamente vilipesa - finanche oggi - una delle nostre maggiori scrittrici di tutti i tempi (da rileggere almeno Canne al vento, Elias Portolu e Il segreto dell'uomo solitario); il secondo, con la sua monumentale opera saggistica ed epistolare (Lettere dal carcere) ha segnato in profondità i destini della politica italiana. E' normale poi che la «nuova Sardegna» sia entrata, o entri anche in conflitto con i vecchi valori, con questa modernità che repentinamente, nel volgere di un secolo, è diventata tradizione (eppure, nonostante le fughe in avanti, rimane ben saldo, anche negli intellettuali più all'avanguardia, il dovere di scavare nella storia letteraria sarda; pensiamo al saggio La parola ritrovata di Giancarlo Porcu sul poeta ottocentesco, purtroppo misconosciuto, Pascale Dessanai).
La tradizone letteraria sarda del '900, comunque, è assai corposa: pensiamo a Emilio Lussu, fondatore del partito sardo d'azione, antifascista, esule in Francia, tra i fondatori del movimento «Giustizia e libertà», autore di libri importanti come Marcia su Roma e dintorni e Un anno sull'altipiano; oppure, più in avanti, alle soglie degli anni '80, al capolavoro di Salvatore Satta, Il giorno del giudizio, definito da George Steiner «uno dei capolavori della solitudine della letteratura moderna»; o, infine, a un libro di forte rottura simbolica e culturale come Padre padrone di Gavino Ledda. Negli anni '80 è emerso uno scrittore di robusta caratura romanzesca (e poetica), Salvatore Mannuzzu, il quale ha affrontato, nei suoi numerosi romanzi, a partire da Procedura fino ad Alice, il tema della giustizia e dell'etica (notevoli i suoi interventi «religiosi» sul quotidiano Avvenire). E, prima della nuova ondata, si è affermato lo scrittore che probabilmente ha più influenzato le nuove leve di scrittori sardi: Sergio Atzeni, autore di libri imprescindibili come Il quinto passo è l'addio e Passavamo sulla terra leggeri (Marcello Fois ha dedicato alla sua memoria, e alla sua misteriosa morte per acqua, una poesia «alla Whitman» nella raccolta L'ultima volta che sono rinato).
E' però negli ultimi dieci anni che la letteratura sarda ha trovato una sua «letteratura di massa», con punte di eccellenza e, com'è ovvio, con opere medie, di puro folclore (un ruolo fondamentale lo ha svolto la casa editrice sarda Il Maestrale, spesso in coedizione con la Frassinelli). Tutto ha inizio, probabilmente, con la consacrazione nazionale di Marcello Fois; ma non bisogna neanche dimenticare lo spartiacque di Pesi Leggeri, romanzo di Aldo Tanchis divenuto film per la regia di Enrico Pau (storia malinconica di boxeur della periferia di Cagliari). Ora, come tutti sanno, gli scrittori sardi sono un esercito: Giorgio Todde, Giulio Angioni, Marcello Fois, Salvatore Niffoi, Flavio Soriga, Milena Agus, Aldo Tanchis e via discorrendo. E questo proliferare di scritture dalla Sardegna deve essere salutato con entusiasmo, non fosse altro che proprio grazie a questo «rinascimento» si sta vivificando e riformulando la tradizione letteraria sarda, fondamentale per l'intera cultura nazionale.
Epperò per cercare di capire cosa sta avvenendo nella letteratura degli scrittori sardi, è necessario distinguere tensioni e linguaggi, stilare graduatorie, tentare un discernimento, magari proprio a partire dalle opere ultime. E se Salvatore Niffoi, con L'ultimo inverno, ripropone una Sardegna compiaciuta e folcloristica (a Niffoi, evidentemente, manca lo sguardo da lontano, fondamentale per chi si confronta con una terra carica di storia, e di stereotipi identitari), Marcello Fois, con Memoria del vuoto, pur affondando rischiosamente le mani in uno stereotipo sardo (il banditismo), riesce, grazie a un linguaggio sapientemente lirico e, d'improvviso popolare, a rendere poetica, «rugginosa», notturna (universale) la storia di Samuele Stochino. Fois cala sulla narrazione lineare della sua storia un manto di suggestioni poetiche, uno stile ferroso, materico, complesso, di chi non racconta la propria terra standoci dentro, ma alla propria terra ritorna, con quel misto di sogno e d'inquietudine che dona l'essere lontani dal centro del proprio racconto. Caratteristica di entrambi (di Niffoi e di Fois) è uno stile ellittico, con inserti dialettali; ma mentre Niffoi è ellitico per sostanziale farraginosità narrativa, Fois lo è in quanto figlio di quella tradizione, di quel linguaggio che sulla chiusura ha fondato il proprio tormento (Gramsci). Pure, il dialetto di Fois è un suono omogeneo al racconto (ha lo stesso suono del racconto), mentre il dialetto di Niffoi è un inserto ex abrupto di puro colore.
Scrittori come Fois hanno l'intelligenza di capire che la storia è una miniera inesauribile di materiali culturali, linguistici, narrativi; è fuggire dalla storia - come fa Flavio Soriga, con esiti per niente trascurabili - ha senso soltanto nella misura in cui si tenta una rilettura del passato stesso (la globalizzazione di Soriga, da lui propugnata, non può cancellare lo stato di fatto che il linguaggio è sempre tradizione, personale e storica). Anche Aldo Tanchis, nel suo ultimo romanzo, Una luce passeggera, non disdegna affatto la storia, il dopoguerra, una narrazione di geometrica evanescenza (Tanchis vorrebbe quasi descrivere con precisione l'invisibile) e, proprio come Fois, trova nel paesaggio (il paesaggio non è mai tradizione) un materiale vivo non naturale, ma quasi culturale (più astratto Tanchis, più romantico Fois). Entrambi vivono altrove: Tanchis a Milano, Fois a Bologna. Ma anche Soriga, autore del dolente e scanzonato Sardinia Blues, vive a Roma. Non è un caso, perciò, che i migliori scrittori sardi vivano e abbiano sempre vissuto lontani dalla propria terra (dalla Deledda in poi).
Scrive Flavio Soriga nel suo ultimo romanzo: «Io, sempre, quando le situazioni sono tragiche, proprio nei momenti terribili in cui tutto precipita e ci sarebbe da disperarsi e piangere e strapparsi i capelli e le persone attorno a me non trovano niente a cui aggrapparsi e si fanno prendere dal panico, io in quei momenti vedo il ridicolo di queste scene che sono così cinematografiche, piccoli o grandi che siano i drammi del momento, io vedo il ridicolo del recitare una parte in questi drammi e sul momento rimango freddissimo, e non riesco a franare, a precipitare, a perdere il controllo». E' una prospettiva chiara, di chi vive un distacco (cinico) dai drammi. Eppure il suo romanzo, dopo aver ridicolizzato pesantemente Grazia Deledda, i nuraghi, dopo aver propugnato un precariato globalizzato, un salvifico Andy Warhol autoctono, dopo averci raccontato tutta la pseudo-modernità dei pub, dei mojito, dei viaggi a Londra, delle estati vip in Sardegna, risulta essere un romanzo doloroso sull'amore, sulla malattia, sul diventare grandi in un clima generale di confusione dei valori (il suo stile, per esempio, deriva dalla prosa frammentaria e orale del primo Paolo Nori e dei padani strampalati; e, più che un blues, sembra una dance). Soriga, quindi, racconta un vuoto, ma tutt'altra cosa è, in sede stilistica, il vuoto poetico e spirituale di Marcello Fois: «Là, per un istante appena, fu tutto chiaro, e fu chiara la distanza, e furono chiari i tempi e i luoghi. Là, dentro a quella memoria del vuoto, quando tutto sembra che sarà e invece è già stato, Samuele Stochino riuscì a piangere». Il discorso sulla Sardegna letteraria, però, è ancora tutto da fare.
Andrea Di Consoli (L’Unità, 18 febbraio 2008)

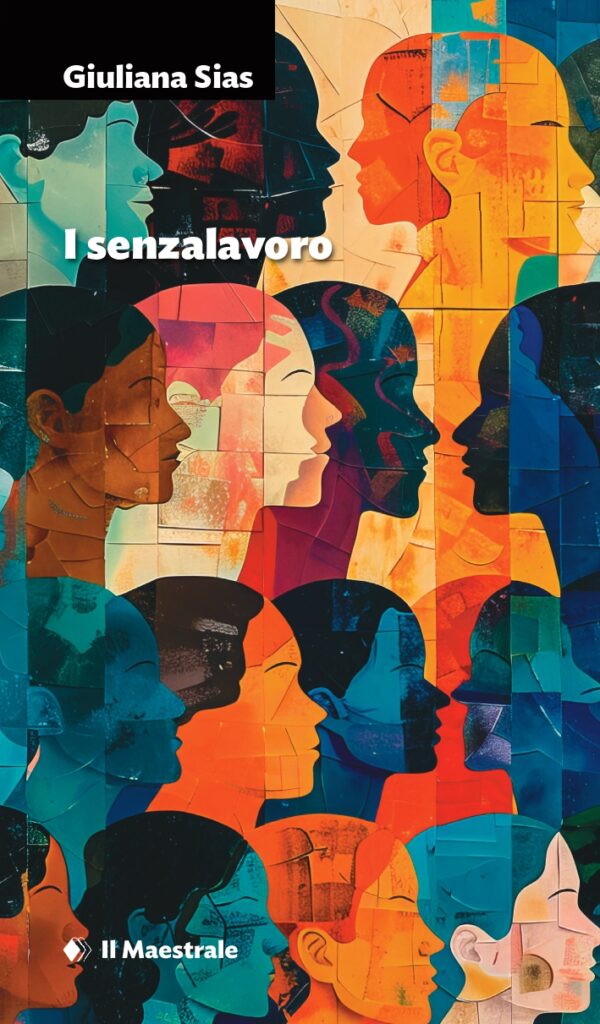

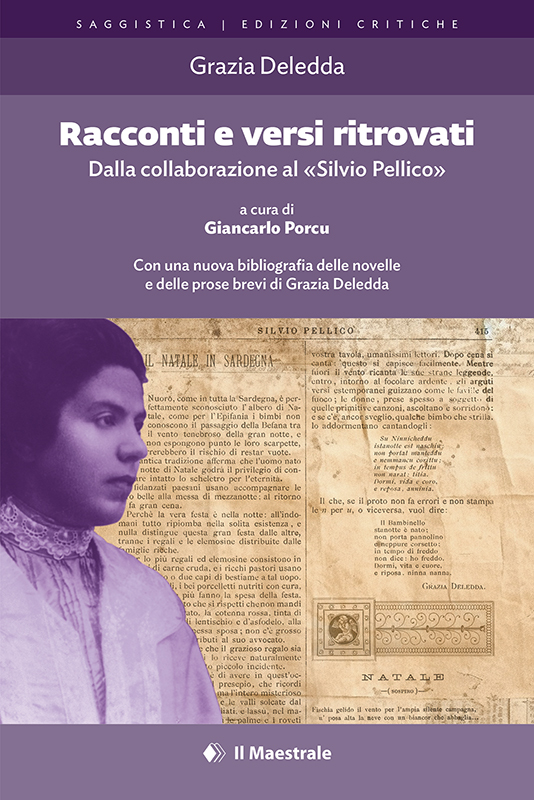

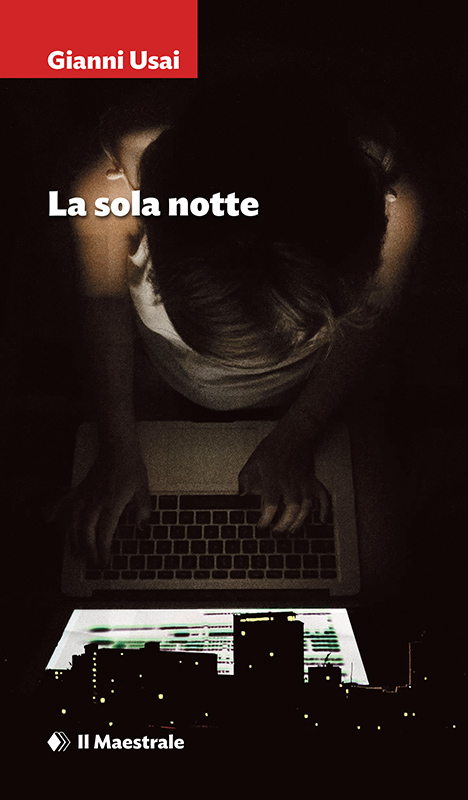









DISTRIBUZIONE : (Gruppo- Mondadori)
A.L.I. AGENZIA LIBRARIA INTERNATIONAL S.R.L.
VIA MILANO 73/75 –
20007 Cornaredo-MI ...
Tel. 0299762430-1-2
Fax 0236548188
E-Mail infoali@alilibri.it
ORARI Dal Lunedì al Venerdì 08:30-12:30 /13:30-17:30
RETE PROMOZIONALE- LIBROMANIA

