
Da una pagina del sito dell’Enciclopedia Treccani: «Contrariamente a quanto si possa credere non si tratta di un vocabolo di vecchia data, ma piuttosto di un neologismo dalla fortuna internazionale. Un dettaglio ancora più sorprendente riguarda il fatto che a inventarlo non sia stato né un filosofo né un poeta, bensì un laureando in Medicina: aveva bisogno di un termine per descrivere la nuova malattia dilagante in Europa». Dopo aver riconosciuto questa patologia nei soldati svizzeri che, mandati a combattere lontano dalle loro terre e dai loro focolari, sviluppavano un profondo struggimento e una grande malinconia, lo studente universitario Johannes Hofer pensò di ricorrere a due termini greci per darle un nome e renderla così reale: unì quindi “nostos” (ritorno a casa) e “algos” (dolore), e intitolò la sua tesi, pubblicata nel 1688 a Basilea, “Dissertatio medica de nostalgia”.
La nostalgia, appunto. È proprio questo sentimento ad aver originato “Il mantello del fuggitivo”, il nuovo libro di Giorgio Todde (Il Maestrale, 192 pagine, 16 euro), e ad avergli conferito senso e sostanza. Il cagliaritano – ipotizziamo, e ci scusiamo se lambiamo territori psicanalitici – deve averne provata una di forte intensità verso il suo personaggio Efisio Marini, se sono vere come sono, e possibilmente rivelatrici, due circostanze. Una è che questo sesto romanzo dedicato al pietrificatore-indagatore inizia così come iniziava il primo, “Lo stato delle anime”, ovvero con un conteggio che ha poco del numerico e molto invece del metafisico. «Ad Abinei le case di pietra sono sempre le stesse perché nulla si moltiplica o diminuisce nel paese fossile. Lo stato delle anime della comunità colpisce per il fatto che i morti sono compensati con esattezza dai nati e per questo motivo le case sono le stesse e invariato il numero dei fuochi. Anche gli animali, come gli uomini, nascono e muoiono in misura uguale», leggevamo nel 2001; e leggiamo oggi: «Nell’ospedale degli Incurabili i malati sono sempre lo stesso numero, si entra e si esce nella stessa misura. Il frate economo mantiene uguale la quantità delle brande e degli orinali che la suora numera ogni giorno e il calcolo torna sempre perché il Contabile degli Incurabili ha stabilito che la differenza tra vivi e morti deve essere pareggiata dai colerosi». Una rievocazione? Sì; e aggiungiamo: in tutti i sensi. Perché l’altra circostanza, unita stretta alla prima, è che nell’ultimo tassello, il quinto, “L’estremo delle cose” del 2009, il Marini, vecchio e appesantito, l’avevamo lasciato morto e sepolto. Todde, insomma, non ha voluto (o potuto) farlo riposare ancora nel Regno letterario dei più, e lo ha richiamato a sé e a noi lettori. Che di quel medico testardo nel voler comprendere a ogni costo, insolente, fragile, spesso puerile e ugualmente spesso pronto a salire in cattedra con l’indice puntato quando pretende di avere qualcosa da insegnare, avvertivamo eccome la mancanza.
Le faccende di “Il mantello del fuggitivo” sono cronologicamente precedenti rispetto a quelle di “L’estremo delle cose”: per l’esattezza, risalgono a quando Marini ha trentacinque anni e da otto si è trasferito in Campania con la moglie Carmina e con Rosa, la sola figlia rimastagli dopo la scomparsa del piccolo Vìttore. Napoli, certo, con le sue voci, la sua folla, il lavoro agli Incurabili e gli esperimenti che gli danno fama; ma il legame con la Sardegna, e più ancora quello con la Cagliari che pure l’ha ripudiato, è tutt’altra cosa: «Per strada, da quando è tornato, guarda ogni cosa, saluta e osserva ogni persona e si chiede perché prova la sensazione di essere attirato dal suo mondo familiare, dall’ascendenza del suo sangue, richiamato dalla casa e dal letto dove è nato. Sente con certezza che questo luogo dove ha respirato per la prima volta è il suo luogo, che l’acqua sotto il promontorio è il suo fonte battesimale. Prova, lo ha chiaro in testa, un sentimento che disprezzava, la nostalgia, inevitabile, dolorosa e, da qualche giorno, desiderata, cercata».
La nostalgia, appunto. Efisio non può eluderla, deve farci i conti. Ma li deve fare anche, sulla sponda isolana e sulla sponda peninsulare del Tirreno, con gli assassinii della tredicenne Marcellina e dell’avvocato Ernani Massente, che in qualche modo finiscono per coinvolgerlo; con la fresca vedova Massente, Alcina, che lo strega con un gesto misterioso, come sa fare da quando è nata con chiunque voglia affatturare; con il Maestro Thalberg, non meno meditabondo e complicato di lui, tutto teso a investigare l’infinito sui tasti del pianoforte che picchia e addomestica come pochi; con Argante Solera, che, simile a un feudatario, comanda sul molo dello Scorpione, e che combatte un fegato compromesso con il cibo; con chi gli chiede di eternare un caro defunto, o di essere eternato lui quando sarà venuta l’ora, tramite i suoi sali bianchi di silice che proibiscono al corpo di marcire; con la consorte, che ormai da tempo gli nega sguardi e parole, imprigionata nel dolore del lutto; con tipi dal carattere bizzarro, a partire da Don Bebeto, il prete di famiglia detto Bardùnfula, trottola, perché «cammina ruotando, veloce». E poi, sopra il resto, con la Paura e con la Morte.
La scrittura di Giorgio Todde, e non si potrebbe esserne più felici, si riconferma, anche ad allargare lo sguardo al panorama letterario nazionale, unica e di qualità superiore, capace com’è di raccontare il quotidiano, persino nei suoi aspetti più materici, con un’elusività quasi trasfiguratrice: «Questi stracci si incontrano, si promettono gioia, poi con una regolarità geometrica legata allo stesso compito, dopo la promessa, si tradiscono con altri stracci e promettono altra gioia che non arriva mai».


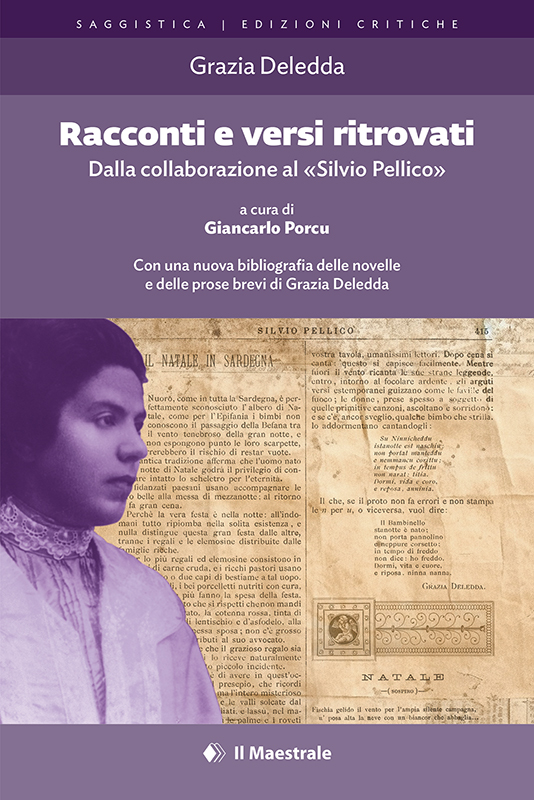
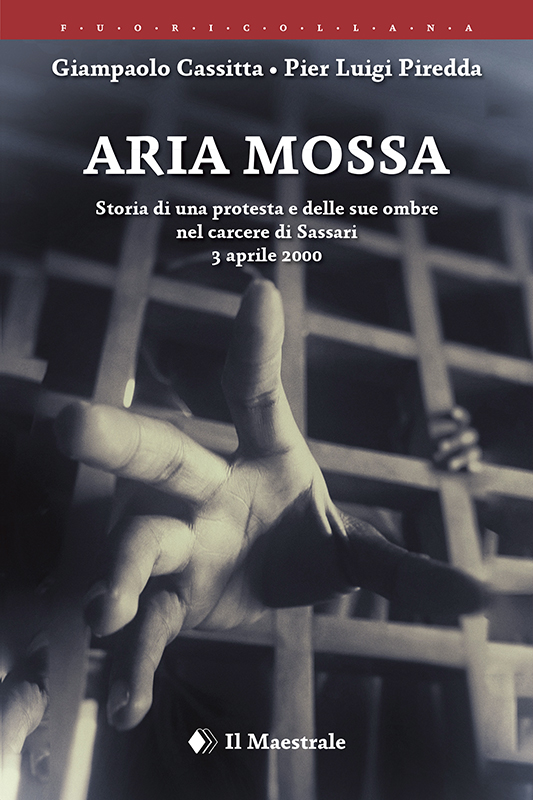

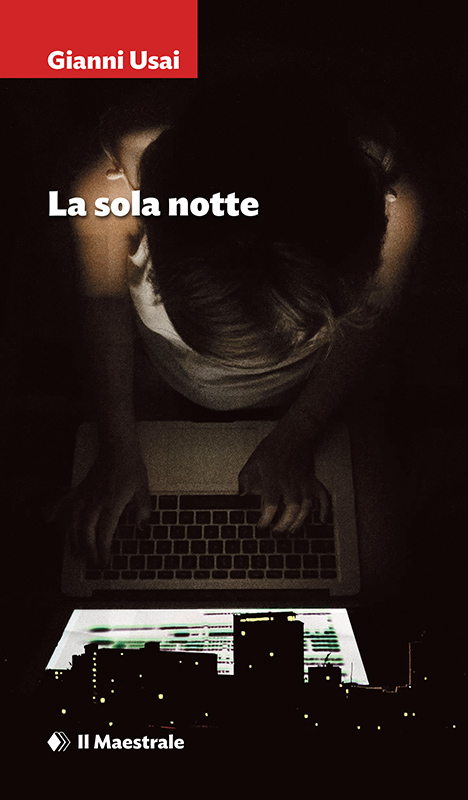









DISTRIBUZIONE : (Gruppo- Mondadori)
A.L.I. AGENZIA LIBRARIA INTERNATIONAL S.R.L.
VIA MILANO 73/75 –
20007 Cornaredo-MI ...
Tel. 0299762430-1-2
Fax 0236548188
E-Mail infoali@alilibri.it
ORARI Dal Lunedì al Venerdì 08:30-12:30 /13:30-17:30
RETE PROMOZIONALE- LIBROMANIA

